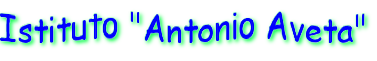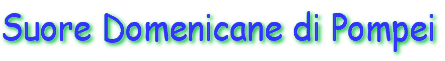Realizzazione della Basilica
Il Santuario
*Pianta della Chiesa - Il disegno del Santuario *Le prime pietre portate sulle spalle *Misure del Santuario *Consacrazione del Santuario - 24.05.1891 *Impressione e Ricordi *La festa dei Sig. Forestieri 1886 *Facciata del Santuario *Inaugurazione della facciata - 05.05.1901 *Cinquantesimo Anniversario del Santuario - 07.05.1939 *La Sacrestia


Il disegno del Santuario.
La prima pietra dell'edificio, che un giorno sarebbe diventata Casa del Signore nella landa di Pompei, era solennemente adagiata sotterra, come a base di novella Arca noetica, la quale, senza nostra saputa, era destinata a riconciliare con Dio la umanità colpevole nello scorcio del Secolo Decimonono, non che la prossima generazione del Secolo Ventesimo.
A noi, nella foga dei desideri ove eravamo accesi e trascinati, pareva di aver felicemente superate le maggiori difficoltà che sin dalla prima ora si erano presentate per giungere a quel giorno sospirato: gettare le basi di un Tempio al Dio vero sulla terra de false divinità!
Ma poi che le feste furono passate e la freddezza del consiglio ebbe preso luogo, cominciammo a travedere cotali nuove difficoltà che mai innanzi non avevamo trovate tante. In prima, quanto sarebbe per essere vasta questa nuova Chiesa? quanto lunga? Quanti altari, quante cappelle? La prudenza evangelica consigliava di non porre mano a cosa superiore alle nostre forze. Un avviso del santo Vescovo di Nola era a quella conforme: - «Non spendete più di quanto possedete» ci aveva egli suggerito. Ma d'altra parte risonava ancora nei nostri orecchi un'altra sentenza, frutto della lunga esperienza di quel savio Prelato: - «Quando si ha da fare dalle fondazioni una Chiesa, non si vuole guardare al numero presente degli abitatori di un luogo, ma al numero ascendente di venti anni appresso». Di che la preveggenza consiglierebbe si facesse una Chiesa ampia si da contenere un duemila persone, tenuto calcolo dell'aumento di dieci volte in più della popolazione presente. Come conciliare le due opposte sentenze?
Il medesimo Monsignor Formisano aveva trovato questa semplice soluzione. - «Fate le fondazioni non tutte d'un tratto, ma a pezzi a pezzi, secondo che vi basterà il danaro. Poi innalzerete due mura su quei pezzi di fondazioni, quindi un arco, una vòlta: tra quelle due pareti laterali elevate temporaneamente una terza di fronte che li chiuda, ed ecco bella e fatta una chiesuola. L' anno prossimo smantellerete le pareti di mezzo, e continuerete le fondazioni, e poi due altre mura su, con archi e vòlta, ed avrete il doppio della lunghezza. E cosi di anno in anno sfondando ed erigendo, voi allungherete la chiesa, solo se avrete voglia e danaro».
A noi, stranieri affatto all'architettura, ci parve quello savio consiglio, tanto più che salvava la prudenza e favoriva la preveggenza del futuro accrescimento di popolazione.
Ma ad ogni modo sorgeva un'altra incognita. Le fondazioni avrebbero a costruirsi tutte d'un getto, a tela come dicono, per essere più solide, ovvero ad archi e pilastri per essere più economiche? Dato pure che si avesse a favorire l'economia, di qual larghezza sarebbero per essere questi archi e questi pilastri?
Ancora, erigendo un Tempio per duemila contadini a venire, quale forma era da prescegliere più riuscire a contener popolo villereccio, ossia quale stile si sarebbe seguitato? a colone o a pilastri? ad una navata ovvero a due? a croce latina o a croce greca? con vòlta di fabbrica, oppure con solaio a tetto ed a legname? Tutto questo per me, che avevo speso i miei anni alla letteratura ed alla filosofia, non che a svolgere i digesti e le codificazioni antiche e moderne, che fanno a calcio con le matematiche, era un problema di difficile soluzione. A dir corto vi erano mestieri di un disegno architettonico, secondo il quale cominciare le nostre operazioni.
Ma, invitare un architetto! Oibò: la Marchesa Filiasi e Mons. Formisano ci avevano messo nell'animo un gran timore di chiamare architetti per una Chiesa rustica di poveri contadini, quando a pagar dritti e spese e viaggi di Architetto vi avrebbe
voluta la metà delle offerte con tanto stento raccolte. Le spese per un Architetto era meglio invertirle in fabbrica per accelerare il compimento della Chiesa. Anche questo era entrato nella mente mia a modo di convinzione.
Ma intanto un disegno era indispensabile. Come fare? Ossequiosi sempre alle parole dell'antico Pastore, ci conformammo al tutto ai suoi consigli. Deliberammo di fabbricare a brani: a questo modo schiveremmo la prima morsa che ci stringeva, cioè di dovere definire di presente la lunghezza dell’edificio. Ma, e la larghezza di esso? Non poteva farsi di meno di determinarne sin dal principio la larghezza per potere incominciare i laterali cavamenti.
Non mi spersi d’animo. In cima a tutti i miei disegni vi era l'attendere ad innalzare un Tempio al Dio vero in questa desolata piaggia, e fare invocare da un popolo nascente a propria tutela la Regina delle Vittorie con la preziosa Corona del suo Rosario. Qualunque foggia o stile di Chiesa mi avrebbe menato a cotesto risultamento: era quindi inutile darsi di ciò altro pensiero. Quattro mura bianche di calce, una vòlta semplice, anch'essa bianca di calce, ecco tutto il bisognevole: ed il popolo entrerebbe senza disagio ad adorare e lodare il Signore.
Oltre ciò a me passava per la mente un altro pensiero. Avevo visto presso Scafati una Chiesa spaziosa abbastanza, atta a contenere oltre a mille persone, dedicata alla Madonna così detta dei Muroli, ad unica navata, a croce latina, tinta a calce, la quale le dava un'aria allegra e pura. Ed oh come mi sarei reputato felice se avessi avuto una Chiesa somigliante nella mia Valle! Informatomi, quei cittadini vi avevano durato attorno non meno di trent'anni a costruirla, e vi avevano speso non meno di trentamila Lire!... Trent‘anni di fatiche, e trentamila lire in contanti! Vi era ragione da sgomentare ai primi passi. E chi avrebbe raccolta tale somma in Valle di Pompei tra poveri contadini? E poi chi mi assicurava la vita per tanti anni essendo io cosi infermo?
- Non siate egoisti, aveva più volte ripetuto il nostro Vescovo, non vogliate pensare per voi, ma per i posteri. Voi incominciate, gli altri finiranno. Queste parole risuonavano sempre nell'animo nostro, Noi dovevamo cominciare, senza pure pensare di vederne il compimento. Dunque, fiducia nello aiuto della Provvidenza, ed avanti! Noi cominceremo, gli altri finiranno. La Chiesa della Madonna dei Muroli forma la nostra invidia? E la Chiesa dei Muroli sia il modello, a cui si conformerà, benché più poveramente, la futura Chiesa di Pompei.
Fermato tale divisamento, non sapendo far di meglio, invitammo il nostro capo muratore di Scafati, Pasquale Vitelli, a recarsi con noi a quella Chiesa. Ed un bel giorno, ci andammo insieme, con l'amico Sacerdote D. Gennaro e con la Contessa. E messici dall'uno dei lati, ne pigliammo con una cordicella i disegni e le dimensioni quanto a lunghezza ed a larghezza. Quindi accortomi che D. Gennaro aveva una propensione naturale alla meccanica, lo sollecitai di mettermi in rilievo un disegno topografico di una Chiesa che fosse a quella al tutto somigliante. E il buon prete fu presto a contentarmi; e tracciò su di un foglio di carta un edificio che voleva dir Chiesa, foggiata ad unica nave con quattro cappelle. A dir vero quel disegno doveva essere qualche cosa di grottesco, perché mostratolo appena a qualche perito dell'arte, destò l’ilarità come di uno scherzo puerile. Ma a noi, cui bolliva il sangue nelle vene, ed a cui cruciava ogni ora d'indugio, questa traccia parve più che sufficiente per dar inizio al lavoro.
Il medesimo amico D. Gennaro mi propose, per ottenere maggiore economia, di far le costruzioni non ad appalto, ma, come qui si usa, in economia, cioè pagare i lavori a giornate; ed egli, insieme con suo padre, che vedemmo presente alla funzione della prima pietra, e che aveva fatto il voto di sovrintendere gratuitamente alle costruzioni, vi avrebbe diligentemente sovrastato curandone il modo di pagamento. Venne infine tra noi risoluto, che le fondazioni, per risparmiare, sarebbero fatte ad archi e pilastri.
*Pianta della Chiesa su disegno del Cav. Prof. Antonio Cua
La Chiesa del SS. Rosario di Pompei si trova sulla Consolare che da Torre Annunziata mena a Scafati – alla distanza di circa mezzo chilometro dall'anfiteatro di Pompei.
È preceduta da ampia area di forma rettangolare, che serve di accesso dalla Via pubblica alla Chiesa. Il fronte della Chiesa è ripartito in tre sezioni. Quella a sinistra di chi guarda, serve d’ingresso alla provvisoria Cappella della SS. Vergine del Rosario. La porta centrale che ne è la principale, ha l’ingresso con breve scala che immette nella Chiesa. Ed infine la parte destra con altro ingresso in corrispondenza del primo dà adito alla Parrocchia del SS. Salvatore di Valle di Pompei.
Il Sacro Tempio occupa da sé solo uno spazio rappresentato dall’area di metri quadrati 450. Presenta la forma di croce latina ad una sola navata. Subito varcato l’ingresso, vi è la tribuna dell’organo con a sinistra una scala di ascesa, ed a destra la torre dell’orologio. Nei due lati della navata principale vi sono quattro cappelle tutte incassate, oltre la navata stessa, comunicanti fra loro fino alla crociera, la quale ha i due bracci lunghi al di là del fondato delle cappelle. In continuazione della navata è ricacciata la cona, con la parete di fronte a squadro. La copertura della navata, i bracci della croce e cona, sono a volta in muratura, la figura a botte lunetta con ampi finestroni a luce libera. Nell’intersezione dei due bracci della Chiesa si erge al cupola, un tamburo a finestroni o su tutta sormonta il torrino con cupolino. L’esperienza dello scorso anno ha dimostrato che la cona attuale, per la concorrenza di fedeli nella crociera, non può essere servita con speditezza e comodità tanto che al presente è già inoltrata la prostrazione della medesima, in modo da soddisfare completamente le esigenze del sacro culto nei momenti di folla maggiore nella Chiesa, la quale, a lavoro compiuto presenterà la forma del tipo che ci pregiamo presentare. L’opera, com’è di presente, è completa di rustico e di copertura al cielo.
Le fondamenta furono iniziate nell’8 di Maggio del 1876.
Il lavoro è stato diretto per la parte costruttoria dall’egregio Ingegnere Professore Cavaliere Antonio Cua, a cui tributare si debbono i dovuti encomi pel modo come ha ideato e condotto i lavori al suo termine, e per il raro disinteresse mostrato a rinunciare ogni compenso, e spendendo anche del proprio per accedere continuamente sui lavori.
Ora comincia un secondo periodo per la Chiesa di Pompei, La decorazione. Il concetto informatore di questo è di ottenere il massimo decoro per la “Casa della Nostra Signora”; tutto deve ispirare devozione, ed ogni parte collegata al tutto formare deve la magnificenza del Tempio Cristiano votato alla Regina dei Cieli.
Il compito è arduo, se si ponga mente alle difficoltà artistiche, in relazione dei mezzi a disporre, tenendo a fronte l’antica Pompei, ove il lustro dei tempi pagani con i loro avanzi ci additano quale esser doveva la loro magnificenza e splendore. Nulla sarà risparmiato a che la Chiesa raggiunga il suo perfetto e completo risultato.
Animati da santo entusiasmo, sapremo cavar profitto da ogni cosa, e speriamo che i già iniziati lavori in breve volger di tempo basteranno in una prossima festività ed additare il genere prescelto a compiere un’opera tanto bellamente cominciata. Il punto culminante di tutto sarà la collocazione della Vergine insieme col suo altare, e di ciò fin da ora promettiamo fra non molto darne conoscenza ai nostri lettori con l’illustrazione, ove occorra.
(Autore: Ing. Giovanni Rispoli)
(Da: Il Rosario e la Nuova Pompei – Anno I - 1884)
Per portare avanti l'opera con poco danaro ed insieme con grande alacrità, il vecchio Parroco Cirillo che presentammo ai lettori come primo Parroco di Pompei, propose di invitare nella prossima domenica tutti i coloni e i vetturini della Valle, che offrisse ciascuno chi l'opera sua in giorno di festa e chi un carro di pietre, e dove un trasporto di terra vulcanica detta pozzolana, e dove un po’ di calce ed altro materiale atto a costruzione.
Era a cinquecento metri da quel luogo, e propriamente sull'angolo occidentale del feudo De Fusco, aperto un piccolo cavo di pietre vulcaniche da un Custode degli Scavi di Pompei, che ha nome Pietro Paolo Vitelli, il quale a proprie spese e per fabbricare una sua casa aveva fatto ivi alcuna provvisione di pietre. Allorché vide la funzione della posa della prima pietra del tempio, dispose in cuor suo di offrire per l’opera santa dodici metri cubi di pietre, ed aspettava i carretti che le trasportassero.
Venuta la domenica, che fu quella seguente dell’8 maggio, la quale in quell’anno cadde il 14 del mese, essendo radunato tutto il nascente popolo Pompeiano, quel Curato si levò su a predicare loro, dicendo tra le altre cose: «che Dio si era mosso a pietà di essi, disponendo che si innalzasse una chiesa ove potessero tutti raccogliersi insieme, e udire la Messa e farsi buoni cristiani; e che gran merito era all'uomo l’erigere una Chiesa a Dio. Doversi ognuno tenere onorato assai di potere con le sue mani mettere una pietra all'innalzamento della Casa ove abiterà il Signore. E poiché il Custode della vecchia Pompei offrì delle pietre, sarebbe stata opera meritoria, di pietà e di penitenza, il trasportarle sulle proprie spalle, quasi a dichiarazione di servitù verso il Signore del Cielo e della terra».
La parola del sacerdote non cadde su terreno sterile. Ogni persona che qui vi erano, maschi e femmine, grandi e piccoli, seguitarono i desideri e gli esempi del proprio pastore. Mossesi in capo a tutti il vecchio Curato, e dietro a lui seguivano, a modo di processione, i due fratelli Sacerdoti Federico, e poi la Contessa con i suoi quattro figliuoli, e tutti i servi della casa e tutti i coloni, e poi fanciulli e fanciulle e il popolo Pompeiano frammisto. Ed era un tenero spettacolo a vedere tante persone di ogni età tornarsi per la via provinciale che da Napoli mena a Salerno, tutte curve sotto il peso di sassi che si portavano addosso con una fede umile e sincera, ma ad un tempo forte e sprezzatrice di ogni umano rispetto. Anche io fui del numero degli avventurati, portai il mio sasso, e forse quella nobilissima umiliazione mi fruttò spazio di vivere sino a vedere oggi quasi compiuta la Chiesa del Signore! Anche la Contessa, anche la sua figliuola Giovannina trasportarono un sasso; e questa dodici anni dopo quel giorno avrebbe scampato la morte per quella chiesa a cui portava una pietra. Anche il primogenito, il Conte Francesco de Fusco, ebbe quest'onore; e chi lo avrebbe detto? dopo quindici anni anch'egli per quella chiesa sarebbe tornato da morte a vita! Oh come largamente ricompensa Iddio, anche in questa vita, chi a Lui serve; ed oh di quale speciale predilezione guarda il Signore tutti quei che concorrono ad innalzargli templi ed altari sulla terra, donde Egli si possa comunicare con tutte le sue creature!
Ciascun di noi in quel momento era compreso da una fede inesprimibile: il nostro pensiero non precorreva certo i futuri destini di questa chiesuola che allora si faceva per contadini. No: il pensiero dominante era fare adorare Dio in questo luogo dove non era convenevolmente adorato, e rendergli gli atti di lode, di adorazione e di amore che ogni creatura deve al suo Creatore e Signore.
Oh come ci sentiamo oggi felici tutti noi che ricordiamo l'atto di umiltà e di penitenza che compimmo in quel giorno di misericordia! Ripensare che noi, con le proprie mani abbiamo messo un sasso alle fondazioni di un tempio del Signore! e di qual tempio? di quello che in capo a 15 anni è divenuto inaspettatamente Santuario mondiale!...
Oh, se in quella domenica 14 di maggio 1876, qualche incredulo ci avesse visti sulla via provinciale Napoli Salerno, curvi sotto il peso di un masso, trafelati e molli di sudore sotto i raggi di un vivido sole di maggio, fermarci di quando in quando a riprender lena, posando la grossa pietra sul parapetto della via, e indi a poco riabbracciare il peso e compiere frettolosamente il cammino come se un padrone ci sollecitasse alla schiena; quell'incredulo ci avrebbe riso indubitatamente in faccia. Noi quel giorno, presi da unico sentimento, dalla fede, certo non gli avremmo dato risposta. Ma oggi, dopo quindici anni da quel giorno, dopo tanti manifesti segnali di misericordia dati al mondo da Maria da questo tempio, oggi avremmo lasciata quella pietra sulla sponda della via, e saremmo corsi a lui, e lo avremmo abbracciato, e con dolce violenza di affetto lo avremmo trascinato qui ai piedi di nostra Madre, a vedere i prodigi del Signore sulla terra che fu dei gentili. Lo sguardo sereno e dolce della nostra Regina non lo avrebbe fatto tornare indietro senza una benedizione. E la benedizione di Maria è sempre apportatrice di fede e di pace. Oh, beato colui che ama ed onora così dolce Regina!
(Continua)
(Avv. Bartolo Longo)
(Da: Il Rosario e la Nuova Pompei – Anno VIII - 1891)
*Misure del Santuario di Pompei
L’attuale tempio è il risultato dei lavori di ampliamento dell’originario Santuario (anno 1891) effettuati dal 1934 al 1939. In realtà la Facciata fu inaugurata nel 1901 ed il Campanile nel 1925. Perciò il complesso è sorto in vari tempi e fasi.
Il primitivo Santuario (mq. 420), costruito su disegni del prof. Antonio Cua e del prof. Giovanni Rispoli, era a croce latina, con una sola navata culminante con una cupola di 29 metri d’altezza.
Dimensioni della Basilica prima dell’ampliamento:
Lunghezza dall’ingresso all’abside mt. 55.50
Larghezza della navata mt. 13
Larghezza della crociera mt. 20
Dimensioni della Basilica dopo l’ampliamento:
Lunghezza dall’ingresso all’abside mt. 85.50
Larghezza complessiva delle tre navate mt. 32
Lunghezza della crociera mt. 54
Altezza della cupola (compresa la croce) mt.57
Superficie della Basilica mq 2.000, capace di accogliere circa 6000 persone.
Colonne di granito n. 21 da ml. 6.30 diam. 0.75
Colonne di granito n. 16 da ml. 5.00 diam. 0.66
Colonne di granito n. 32 da ml. 2.88 diam. 0.42
Colonne di granito n. 8 da ml. 2.08 diam. 0.32
Colonne di marmo n. 2 da ml. 6.40 diam. 0.85
Colonne di marmo n. 8 da ml. 3.66 diam. 0.54
Nel 1931 il Prelato di Pompei Mons. Antonio Anastasio Rossi ne deliberò l’ampliamento, esponendo i concetti fondamentali all’arch. Mons. Spirito Chiappetta presidente della commissione d’Arte Sacra della città del Vaticano.
Approvati i progetti e i modelli e sottoposti all’esame del Papa Pio XI, nel 1933 iniziarono i lavori di demolizione delle vecchie costruzioni; il 7 maggio 1934 venne posta la prima pietra.
Per non interrompere nemmeno un giorno l’afflusso dei fedeli e lo svolgimento delle sacre funzioni, si dovettero superare particolari difficoltà nella esecuzione dei lavori.
L’insieme delle costruzioni è armonizzato da strutture contrastanti, in perfetto equilibrio di masse, studiato in modo da non subire effetti di spostamento per qualsiasi causa.
L’attuale Santuario è a croce latina con tre navate.
Le due navate minori che hanno tre altari per ogni lato, si prolungano sin dietro l’abside in un ambulacro arricchito da quattro cappelline semicircolari.
Conclusione
Il
Santuario è stato costruito in tempi diversi. L’originario, a croce latina con
una sola navata, fu eretto tra il 1876 e il 1891, su progetto del professor
Antonio Cua dell’Università di Napoli, e misurava 420 mq. Per accogliere i
numerosissimi fedeli, tra il 1934 e il 1939, durante l’episcopato
dell’Arcivescovo Antonio Anastasio Rossi, il Santuario è stato ampliato,
passando da una a tre navate e mantenendo la struttura a croce latina.
Il
progetto fu ideato dall’architetto e sacerdote Monsignor Spirito Maria
Chiapetta, che ne diresse anche i lavori. Le due navate minori, che hanno tre
altari per ogni lato, si prolungano sin dietro l’abside in un ambulacro
arricchito da quattro cappelline semicircolari. L’insieme delle costruzioni è
armonizzato da strutture contrastanti, in perfetto equilibrio di masse,
studiato in modo da non subire effetti di spostamento per qualsiasi causa.
L’interno, di 2.000 mq, può accogliere circa 6.000 persone. La cubatura totale
è di 40.000 metri. Negli ultimi anni, il Santuario è stato sottoposto ad
importanti lavori di restauro che hanno riguardato affreschi, mosaici,
sculture, opere in marmo, quadri. Tali interventi hanno permesso il ritorno all’antica
bellezza, velata dal passaggio del tempo e dagli agenti atmosferici. Il
restauro è ancora in corso.
Ě costruita a doppio ordine, con portico a tre arcate, sul modello delle basiliche romane, tutta in travertino del monte Tifana, in S. Angelo in Formis (Caserta): la stessa pietra servì a Masuccio Secondo per la torre di S. Chiara in Napoli (1328) ed a Luigi Vanvitelli per il palazzo reale di Caserta (1752). Su progetto del prof. Arch. Giovanni Rispoli, di Napoli, la costruzione fu iniziata il 15 maggio 1893, ed inaugurata il 5 maggio 1901.
Il costo di £. 1.700.000 fu coperto da raccolte, anche minime, tra 4.000.000 persone che da ogni paese risposero all’iniziativa di Bartolo Longo. Nelle intenzioni del Beato doveva essere, e realmente fu, il plebiscito del mondo per la pace universale.
Essa fu cominciata prima che lo Czar di Russia convocasse le potenze al Congresso dell’Aia. Bartolo Longo fu anche invitato a partecipare al Congresso Internazionale di Glasgow ed i promotori di esso ne proposero la candidatura al premio Nobel per la Pace.
La proposta fu accantonata perchè avversata da alcuni di ispirazione laicista, ma il Longo fu eletto membro della celebre Howard Association di Londra e socio onorario di molte società filantropiche in Europa ed in America.
L’ordine inferiore del monumento è di stile ionico, decorato da quattro colonne binate di granito rosa, lucidate a specchio nel corpo centrale, e di capitelli marmorei sui pilastri delle arcate. Tra i due ordini corre un fregio di granito con la scritta in lettere cubitali di bronzo:
VIRGINI – SS. ROSARII – DICATUM
L’ordine superiore è di ricco stile corinzio con colonne binate di granito grigio, cornicione e timpano di mensole scolpite.
Al centro si apre la Loggia Papale
Il 21 ottobre 1979, il Papa Giovanni Paolo II, in visita a Pompei, si affacciò dalla Loggia per la recita dell’Angelus e per impartire la benedizione alla folla presente ed al mondo intero.
Si avverava una profezia del Beato: ”un giorno, da questa loggia vedremo la bianca figura del rappresentante di Cristo benedire le genti accolte in questa piazza, acclamanti la Pace Universale
A coronamento del finestrone della loggia, un angelo di bronzo, e più in alto lo stemma marmoreo di Leone XIII. La facciata culmina con la colossale statua della Vergine del Rosario, opera dello scultore Gaetano Chiaramente, ricavata da un solo blocco di marmo di Carrara, del peso di 180 quintali.
In corrispondenza dei due finestroni laterali, in due tondi, sono posti un orologio elettrico a sinistra ed una meridiana sulla destra.
Alle spalle della “Loggia Papale”, in un vastissimo salone, è sistemato l’Archivio Storico Bartolo Longo dove sono custoditi innumerevoli documenti storici.
Nel pronao della Basilica si aprono quattro nicchie con le statue del beato Luigi Guanella, (Arnaldo Gelli – 1970) del beato P. Ludovico da Caloria (Arnaldo Gelli – 1970) di Santa Francesca Saverio Cabrini (Domenico Ponzi – 1970) e S. Leonardo Murialdo, fondatore dei Giuseppini (Domenico Ponzi – 1970). Proseguendo sul lato destro si può ammirare l’imponente mole dell’edificio.
L’esterno, tutto in travertino di Tivoli lavorato a massi, poggia sopra una fascia di granito che corre tutt’intorno alla Basilica. Sono di granito rosa le colonne a sostegno del cornicione e quelle binate della cupola (del peso di 85 quintali ciascuna) e dei cupolini.
La cubatura totale è di 40.000 metri ,
La copertura metallica della grande cupola, dei cupolini, dei tetti e delle semicalotte sulle cappelle, richiese kg. 55.000 di rame fornito e messo in opera dalla ditta di Saverio Ascolese della vicina città di Sarno. La fornitura dei marmi e la loro lavorazione furono affidate alla ditta Paolo Medici e figlio di Roma.
Intorno, a destra, un ampio giardino di circa 1.500 mq. Che crea un comodo accesso alla Basilica ed alla Cripta.
In questo giardino, trovasi il monumento a San Massimiliano Maria Kolbe, opera di Tarcisio Musto, frate minore conventuale, inaugurato il 16 ottobre 1976, ed uno dei cinque angeli (opera del Cepparulo) che erano sul trono originario della Madonna nel 1887.
Da: Il Rosario e la Nuova Pompei del 1886 di Bartolo Longo
*La consacrazione dell’Altare Maggiore dedicato alla Regina del SS. Rosario
È antico, per quanto vero, il noto adagio: “L’uomo propone, e Dio dispone”. Noi avevamo disposto non solo in cuor nostro e con i divisamenti e con i progetti, ma nei fatti e con convinzioni e con patti con tutti gli artisti ed intraprenditori e marmorai ed incisori, che poi di 8 di maggio 1886 dovesse essere levato e compiuto il Trono e l’Altare della Regina del Rosario di Pompei per farsi la più solenne funzione, la Consacrazione dell’Altare di Maria. La parte grezza del lavoro in fatti e tutta la consegna dei marmi e dei bronzi lavorati si troverà in questo Santuario in tale giorno; ma le cinque statue di bronzo del Cepparulo e le due marmoree del Comm. Maldarelli e la custodia formata di fini marmi e di bronzo e di oro, ed i grandi candelieri dell’altare, e tutt’altro occorrente per celebrare la prima Messa sull’altare di Maria, non potranno essere pronti prima del Mese di Settembre; poiché l’arte non sopporta costrizione fisica, massime quando si vogliono capolavori destinati al culto del vero Dio, come saranno le statue dell’uno e dell’altro artista.
Quindi il giorno 8 del prossimo Maggio, in cui si compirà il primo decennio delle fondazioni del Santuario di Pompei, questa Chiesa presenterà allo sguardo dei devoti pellegrini un grande Museo di arte cristiana, per tanti lavori di marmo, di bronzo, di gesso e di mosaico che dovranno servire per il Trono e per l’Altare della venerata nostra Regina.
Però facciamo anche qui notare ai nostri cari fratelli, come ogni giorno si avvera in questa opera santa quel passo Apostolico: A chi ama Dio, tutto si rivolge in bene, anche il male che noi reputiamo dannevole. In questo fatto dunque, per noi al sommo rincrescevole, di una contrarietà per cagione degli artisti, del non vedere cioè adempiuti i nostri desideri di consacrare l’Altare del Rosario nel giorno di S. Michele Arcangelo, osserviamo una mirabile disposizione di quella infinita intelligenza, che sotto il nome di Provvidenza divina governa il mondo e gli eletti di Dio.
La Regina delle Vittorie voleva che non in un’altra epoca si dovesse consacrare il suo Altare ed il suo Trono, che nel giorno, solenne per tutto il mondo, della festa del suo Rosario, in questo anno appunto, in cui tutto il mondo solennizza l’universale Giubileo del Rosario.
Nella prima Domenica di Ottobre dunque di questo anno 1886, che cadrà il giorno 3 di Ottobre di detto mese, la storia ecclesiastica e civile scriverà nei suoi eterni volumi queste solenni ricordanze:
NELL’ANNO SANTO DEL GIUBILEO DEL ROSARIO
NEL GIORNO SOLENNE DELLA FESTA 3 DI OTTOBRE 1886
IN CUI TUTTO IL MONDO S’INCHINAVA SUPPLICHEVOLE
A RACCOGLIERE DALLE MANI DI MARIA PROFUMI DI GRAZIE E DI MISERICORDIE
REGNANTE SUL SEGGIO DI PIETRO
LEONE PAPA XIII
NOVELLO PONTEFICE DEL ROSARIO
SI CONSACRAVA NELLA VALLE DI POMPEI
IL PRIMO ALTARE E IL TRONO
ALLA REGINA DELLE VITTORIE
O Fratelli e Sorelle dolcissimi al cuor nostro, oh qual sarà l’esultanza di quel giorno! Qual pianto soavissimo non bagnerà quel giorno le nostre gote in considerando tanti misteri di provvidenza che saranno per svelarsi ed adempiersi sotto i nostri sguardi, nel pieno meriggio della nostra vita. Oh, chi avrà la ventura di trovarsi in quel santo giorno, proverà nel suo spirito dolcezza di cielo, che altri hanno già gustato, ineffabili emozioni dell’animo, che saranno un saggio o un preludio di quegli arcani godimenti che fruiscono i beati nel cielo!
Allora si, noi tutti Centoventimila Fratelli e Sorelle del Rosario di Pompei, che abbiamo posto la nostra pietra ad elevare il monumento e l’altare della nostra Regina; in quel giorno, lieti di santo orgoglio, rivolgeremo la nostra parola all’augusto Capo di tutta la Cristianità, al grande pontefice Leone XIII, e gli diremo con voce franca per filiale confidenza:
“Padre Santo, di duecento sessanta milioni di figli che voi numerate nel mondo, noi, formanti una schiera di Centoventimila Fratelli e Sorelle del Rosario di Pompei, abbiamo meglio che gli altri osservata la vostra ispirata parola, di onorare ed esaltare con tutte le forze la Madre di Dio con il suo Rosario, poiché nessun’altro al mondo, in questo anno del Giubileo del Rosario da Voi indetto, consacrerà un monumento ed un altare sotto si glorioso, e spenderà per esso la somma di Centoventimila franchi!” (Bartolo Longo)
Quel 5 Maggio del 1901
“La Sposa dalla faccia bella”
Con queste parole Bartolo Longo indica l’inaugurazione della facciata della Chiesa di Pompei. Il monumento fu costruito con offerte raccolte in tutto il mondo mediante moduli di sottoscrizione ricoperti da oltre 4 milioni di firme.
"Fratelli e sorelle sparse per l’orbe, il Monumento promesso è già innalzato: io vi aspetto il 5 Maggio, prima domenica del mese sacro alla regina del Rosario di Pompei di questo anno giubilare del Santuario pompeiano (1876-1901).
L’invito, o fratelli, è per voi. Il voto, per me. L’augurio per tutti. Vorrei che la mia lingua sapesse tradurvi tutta la foga dei sentimenti, di speranza, di conforto, di giubilo, di vittorie, che si avvicendano nella mia mente e nel mio cuore ogni volta che mi pongo a pensare quel giorno solenne e memorabile, quando si mostrerà la “bella faccia” di questa novella sposa di Cristo.
Io amo la Chiesa di Pompei come sposa dell’animo mio a cui ho consacrato tutti gli aneliti e gli affetti più vivi del mio cuore. Essa è l’oggetto dei desideri per tanti anni nutriti, tra le ansie e le trepidazioni di un cammino arduo e difficile; ed essa sarà la corona della mia vita” (B.L.).
Abbiamo raccolto qua e là degli scritti di Bartolo Longo, pubblicati al cadere del secolo scorso e, di proposito ci asteniamo ad ogni commento per evitare di materializzare espressioni così preziose di intensa spiritualità: l’incanto mistico di un cuore così ardente di fede. Autore del progetto della facciata, fu il Cav. Giovanni Rispoli, napoletano, “ormai per Lui il Tempio di Pompei è la cosa più cara che abbia al mondo. Che i risultati ottenuti gli siano di sprone a raggiungere quella meta che tanto agogna, e che formar dovrà la pagina più preziosa della sua vita artistica” (B.L.). Il Rispoli, professore onorario del Regio Istituto delle Belle Arti di Napoli, architetto di valore, artista geniale, concepì la grande facciata del Santuario Pontificio Pompeiano con amore infinito; sorretto da fede profonda ne diresse magistralmente i lavori alla guida di uomini di fatica, di operai, di artisti.
“Con sentimenti di ammirazione e di gratitudine segnaliamo i nomi della gloriosa falange di artisti, impresari, capi d’arte e fornitori della Facciata Monumentale del Santuario di Pompei.
Uomini valorosi, cui tributiamo il nostro reverente saluto e quello degli innumerevoli devoti di questo Santuario” (B.L.).
Il materiale per la costruzione, era tutto di origine italiana. Bartolo Longo, con orgoglio quasi campanilistico, in un appunto aveva scritto: “Tutto materiale italiano e lavorato da operai italiani in maggior parte della provincia di Napoli e Salerno”. Per la facciata in prevalenza fu impegnato il travertino. Il calcare fu estratto dai fianchi del Monte Tifata, della catena degli Appennini, presso Capua. È uno dei migliori travertini: basti pensare che di esso si servirono Masuccio II, nel 1328, per la costruzione della famosa torre campanaria di S. Chiara in Napoli e, nel 1752, il Vanvitelli per la famosissima Reggia di Caserta. Le cave però erano state abbandonate; B. Longo, con enorme dispendio, le rinnovò affinché la facciata del Santuario di Pompei fosse costruita con gli stessi materiali già adoperati per il Campanile così famoso e per una Reggia così splendida. Al travertino si aggiunse il granito di Gravellona-Toce, ed il bianchissimo marmo di Carrara. Solo per le due piccole colonne che decorano la loggia papale, fu impiegato, per la prima volta in Italia, il granito rosso di Finlandia. Gli unici due pezzi stranieri sulla facciata del Tempio.
A tale proposito B. Longo scrisse: “Anche la Russia ha avuto il suo contingente di benefici: pochi benefici spirituali invero, poiché il suo governo non permette la diffusione di stampe cattoliche, ma la Russia ha mandato le colonne preziosissime di granito rosso della Finlandia che adornano la loggia papale della facciata ed ha ricevuto in cambio l’oro di questo Santuario”. “L’opera pompeiana è l’opera della pace universale, 1900).
La spesa complessiva sostenuta per la costruzione dell’intero Monumento ammontò ad un milione e settecentomila lire; era costruita dalle generose offerte raccolte in tutte le parti del mondo mediante moduli di sottoscrizione ricoperti da oltre quattro milioni di firme. I moduli, rilegati, formano una serie di otto grossi volumi e rappresentano il plebiscito dei popoli per la pace universale, secondo il concetto espresso dal promotore del plebiscito stesso: l’Avvocato Bartolo Longo.
La cerimonia dello scoprimento della facciata era stata fissata per il 5 Maggio del 1901 alle ore 12. Il programma della solenne inaugurazione del Monumento, pubblicato in marzo dello stesso anno, prevedeva, tra l’altro, a grandi linee: L’esecuzione dell’inno della pace universale ed il discorso di Bartolo Longo incentrato sul ringraziamento solenne delle persone che con la fiducia in Lui, con l’offerta e la fede, avevano consentita la realizzazione di un’opera oltremodo ardimentosa.
Alle ultime parole dovevano cadere gli ampi velari che coprivano la novella facciata mentre echeggiavano le note della marcia trionfale eseguita dalle bende musicali riunite; in concomitanza, le campane del Santuario, suonando a distesa, avrebbero annunziato a tutta la Valle del Sarno l’inaugurazione del Monumento alla Pace. Non sarebbero mancati i rituali spari di mortaretti e l’accensione di una miriade di bengali. A chiusura, nutriti stormi di colombi viaggiatori, sprigionati dalle arcate della loggia, avrebbero raggiunto, forieri della lieta novella, le città lontane.
Il programma fu rispettato con meticolosa puntualità. Il 5 Maggio alle ore 12 precise, gli ampi velari che coprivano la facciata caddero; immenso fu lo stupore della folla che si accalcava sulla piazzetta antistante, sui balconi, sui terrazzi dei caseggiati; quelli più lontani si erano persino muniti di binocolo. Il discorso di Bartolo Longo commosse tutti; a noi piace riportare testualmente un passo, forse il più accorato.
L’oratore si rivolge agli operai. “Operai, fratelli miei che per venticinque anni siete stati a me vicini ed insieme abbiamo lavorato, voi con le braccia ed io con la mente, tutti con amore. Fratelli operai, oggi il nostro lavoro è compiuto. Noi ci dovremmo separare, ma i nostri cuori non saranno giammai separati, tra noi ci sarà un perpetuo legame: Gesù Cristo, il primo operaio che è pure la nostra comune aspettazione. E quando io scenderò da questo luogo e mi avvicinerò a quel Monumento, che voi con tanto amore avete lavorato, io bacerò il piedistallo della prima colonna, e baciandolo intendo baciare ed abbracciare tutti gli operai che hanno messo mano a questo Monumento” (B.L.).
Il Maggio del 1901 compendiava i primi 25 anni di storia dell’opera religiosa e sociale in Valle di Pompei; un’impresa singolare sorta nel mezzogiorno d’Italia tramite l’erezione di un Santuario redimito di prestigiose istituzioni sociali, caritative, educative. Si concludeva il primo grande ciclo dell’avventura pompeiana di Bartolo Longo. Un quarto di secolo storicamente più importante, essenziale, più fruttuoso perché ispirato e guidato dalla Provvidenza.
(Autore: Nicola Avellino)
*Un po' di sintesi generale
La Facciata, la cui costruzione iniziò il 15 maggio 1893, fu inaugurata il 5 maggio 1901. Eretta come monumento alla Pace Universale per volontà del Beato Bartolo Longo, è stata costruita a doppio ordine, con portico a tre arcate, su modello delle basiliche romane, in travertino del monte Tifata, in provincia di Caserta (la stessa pietra utilizzata da Luigi Vanvitelli per la Reggia di Caserta). Su progetto dell’architetto Giovanni Rispoli di Napoli, l’ordine inferiore è in stile ionico, con quattro colonne binate di granito rosa, lucidate a specchio nel corpo centrale, e capitelli marmorei sui pilastri delle arcate.
Tra i due ordini corre un fregio di granito con la scritta in bronzo: “VIRGINI SS. ROSARII DICATUM”. L’ordine superiore è in stile corinzio con colonne binate di granito grigio, cornicione e timpano di mensole scolpite. Al centro si apre la Loggia Papale, ornata da due colonne in granito di Finlandia. A coronamento del finestrone della loggia, una testa di cherubino in marmo e, più in alto, lo stemma marmoreo di Leone XIII.
La facciata culmina con la statua della Vergine del Rosario alta 3,25 metri, opera di Gaetano Chiaromonte, ricavata da un solo blocco di marmo di Carrara di 180 quintali, sotto la quale sono poste le scritte “PAX” e “MCMI”.
In corrispondenza dei due finestroni laterali, in due tondi, sono posti un orologio elettrico, a sinistra, e una meridiana, sulla destra. Nel pronao della Basilica si aprono quattro nicchie con le statue dei Santi Luigi Guanella (di Arnaldo Gelli – 1968), Ludovico da Casoria (di Arnaldo Gelli – 1970), Francesca Saverio Cabrini (di Domenico Ponzi – 1971) e Leonardo Murialdo (di Domenico Ponzi – 1970).
Una gustosa pagina di storia scritta da un attento e scrupoloso osservatore dell’ottocento in visita a Pompei (Parte Prima)
“Poniamo in posto di onore questo bellissimo articolo che ci viene regalato dal Chiarissimo Prof. Cav. Cosimo De Giorgi (*), onore della provincia di Lecce, conosciuto in tutta Italia come profondo geologo ed ameno scrittore e poeta”.
È il giudizio che esprime B. Longo pubblicando, nel 1887, l’articolo sul 1° fascicolo de Il Rosario e la Nuova Pompei.
A cento anni dalla stesura di essa – Natale 1886 – si ristampa la gustosa pagina di storia scritta con acume e brio da un attento e scrupoloso viaggiatore-osservatore ottocentesco.
Una escursione nell’autunno del 1886. Impressioni e ricordi
Non par vero, ed è un fatto. In un secolo come questo tanto miscredente e tanto materialista (1), Valle di Pompei (2) sembra quasi un anacronismo, e ci riporta con il pensiero almeno ad un millennio addietro. Allora una chiesa, una cappella, una cripta sacra, un convento, un palazzo baronale divenivano le cellule primigenie intorno alle quali altre se ne aggruppavano per costituire una bicocca, che poi diveniva una terra o un Castello e quindi una Città.
In questa mia Provincia (3) per es. moltissimi paesi ebbero questa origine nel medioevo, tanto sotto la dominazione bizantina, prima dell’XI secolo, come sotto i Normanni e gli Angioini. Potrei citare tra i paesi greci: S. Eufemia, S. Dana, S. Giorgio sotto Taranto, S. Demetrio, S. Potito, S. Teodoro, S. Sotero, ecc.; S. Pietro in Lama, S. Pietro Vernotico, e S. Pietro in Galatina; su quelli sorti al tempo dei Normanni, Cerrate ed Aurio; e nel periodo angioino le due città di Francavilla Fontana e di Martina Franca. Una chiesa diveniva il centro di attrazione per le nuove abitazioni; ed i re, i principi, i vescovi e i feudatari locali – sempre devoti anche tra le loro iniquità (4) – favorivano con privilegi, con donazioni, con franchigie questi incentramenti.
Ma in questo secolo scettico (5) veder sorgere, nella regione più ridente d’Italia, ai piedi di un monte sempre fumante, spesso innivomo (6), circondato da una vegetazione meravigliosa, in un paese intorno ad una chiesa dedicata alla Vergine del Rosario, sembra per lo meno strano, se non vuol dirsi miracoloso!
E dire che la chiesa stessa non ha neppure il carattere della vetustà, ma appena un decennio di vita ed anzi è tuttavia in costruzione (7); e di già intorno ad essa si va formando un gruppo di case, nel quale però si trovano elementi di civiltà moderna che invano si cercherebbero in città popolose e ricche di gloriose e antiche memorie. Valle di Pompei è nota oramai nel vecchio e nel nuovo mondo; e quando saranno rivedute le carte d’Italia, pubblicate qualche anno fa, dall’Istituto topografico militare, sarà certamente segnata questa nuova borgata, a mezza via tra Scafati e Pompei, nel punto oggi designato su quelle carte con i nomi di De Fusco e De Vivo (8).
Io vi giunsi il 3 di settembre di questo anno. Ero venuto da Lecce per la via di Taranto. Dopo aver traversato l’uggiosa Valle del Basento, mi ero fermato qualche ora in Potenza. Rividi le colline e le montagne che circondano questa città e che io ben conoscevo, perché avevano messo a dura prova le mie gambe in una ricognizione geologica della Basilica eseguita nel 1877 per incarico del Comitato geologico.
Do là traversata la Valle del Platano, che continua con quella del Sele, dopo aver dato un saluto alla gloriosa città dei Principi longobardi e di Roberto Guiscardo, ed ai panorami bellissimi della costiera di Amalfi e delle montagne di Cava, di Nocera e di Pellezzano, entrai nella ridente pianura traversata dal fiume Sarno, a ponente della quale si erge nereggiante il cono del Vesuvio, come un faro sempre acceso da Mamma Natura, come un simbolo del nostro carattere meridionale!
Quella pianura gremita di paesi, solcata da vie e da canali, ricca di una flora lussureggiante, piena di vita industriale, lambita ad occidente dal golfo di Napoli, e senza dubbio la più bella d’Italia: “è un pezzo di cielo lanciato in Terra!”
E proprio nel mezzo di questo cielo si eleva maestoso ed elegante il trono alla gran Madre di Dio, a poca distanza dalla Strada Ferrata che da Nocera corre difilato a Torre Annunziata.
Note
Cosimo De Giorgi, Lizzanello (Lecce) 9.2.1842, ivi 11.1.1923.
“Figura di primo piano nell’età del positivismo. Con straordinaria dedizione passava dalla cura dei malati a studiare le condizioni in cui la gente vive, fisiche, igieniche, agricole, e in queste indagini si imbatteva con piacere nell’archeologia, nell’arte, nella storia. Nessuno lo superava, in Italia, nelle sue ricerche geologiche, nello studio di acque, clima, minerali e grado di sviluppo agricolo della sua regione. Si dava perciò a impiantare stazioni per osservare scientificamente e fenomeni del clima, raccoglieva dati, ricavava intuizioni e induzioni, e la sua terra diventava una delle poche delle cui condizioni si poteva già da allora parlare con cognizione sicura. Molto si occupava di acque sotterranee; e a lui si deve se le società ferroviarie potevano approfondire pozzi nelle nostre stazioni, arricchendoli di nuove sorgive. E prese anche l’iniziativa di acquedotti, tali che, molti anni prima di Bari, il capoluogo di terra di Otranto poté risolvere il problema delle acque potabili.
Negli ultimi decenni si rivolse più intensamente agli studi di storia e di archeologia, iniziati molti anni prima.
Aveva cominciato da medico, ma poi non c’è fenomeno, si può dire, della vita salentina che non abbia studiato con maggiore impegno. Né era pago di parlare, scrivere, consigliare, organizzare. Non era uno studioso da tavolino, un paziente collezionatore di notizie, ma, innamorato del suo paese, viaggiò instancabilmente, per la ragione che, per tutta la sua lunga vita, si sentì socialmente impegnato”.
(da: Tommaso Fiore, Formiconi di Puglia. Lacaita, Manduria. 1963, pasdsim)
(1) “O Vergine Immacolata e Regina del Santo Rosario, Tu, in questi tempi di morte fede e di empietà trionfante, hai voluto piantare il tuo seggio di regina e di Madre sull’antica terra di Pompei”.
È l’invocazione con cui B. Longo inizia la sua Novena alla Vergine, siamo sul finire dell’anno 1878. Il secolo miscredente e materialista, i tempi di morta fede e di empietà trionfante sono chiare allusioni al Positivismo: l’indirizzo filosofico condiviso e seguito, sul finire del XIX secolo, da tutti i paesi del mondo occidentale.
Si consideri che il Positivismo, sistema filosofico eminentemente realista, privilegiando esclusivamente il metodo della scienza e ritenendo essere l’unico valido in ogni campo dell’indagine e dell’attività umana, portava a negare qualsiasi espressione di fede. Ne scaturiva in conseguenza la desolante preclusione ad ogni rapporto dell’uomo con la trascendenza.
(2) Antica denominazione del territorio. Si chiamò Pompei dal 29 marzo 1928, con l’istituzione del Comune Autonomo.
(3) Il de Giorgi era nato a Lizzanello in provincia di Lecce.
(4) Forse costretti ad essere “divoti” in segno di pentimento o per espiazione delle “loro iniquità”?
(5) Ancora ribadisce, accorato, il concetto di scetticismo dilagante nel campo della religione e della fede. La profondissima devozione per la Madonna ed il fervore con cui si vanno realizzando le opere pompeiane, stupiscono il De Giorgi al punto di fargli attribuire a miracolo quanto sta accadendo in questa terra.
(6) Si allude al superbo pennacchio di fumo che scaturiva dal Vesuvio. Il suggestivo spettacolo non è più visibile dal 1944, epoca dell’ultima eruzione.
Va ricordato inoltre che a fine agosto 1886 (il De Giorgi arriva a Valle di Pompei il 3 settembre), il dinamismo del vulcano si accentuò al punto che in alcune occasioni si ebbero getti di proiettili e di cenere accompagnati da boati.
(7) È il primo decennio della fondazione della Nuova Pompei ed anche il più fecondo per le opere religiose, caritative e civili realizzate. Si consideri che il Quadro miracoloso della Vergine arrivò a Pompei la sera del 13 novembre 1875 e già l’8 maggio 1876 fu posta la prima pietra per la erezione del grandioso Tempio. Appena cinque anni dopo il rustico della costruzione era già portato a compimento e nel 1883, l’8 maggio, si recita per la prima volta la Supplica: il 14 ottobre dello stesso anno si celebra nella chiesa la prima grandiosa festa del Rosario. Durante l’anno 1884 si apre l’ufficio postale e si ottiene la fermata del treno a Valle di Pompei; si pubblica il primo fascicolo del periodico Il Rosario e la Nuova Pompei; sono in fase di completamento gli Asili Infantili, la Tipografia, le case per gli operai del Santuario, la cupola del tempio, l’Altare maggiore e il Trono della Vergine.
(8) In quell’epoca il territorio – che costituirà l’attuale Comune di Pompei – era diviso in quattro ineguali porzioni di terra assegnate a quattro Comuni diversi e a due Province. La designazione sulle carte topografiche con i nomi di De Fusco e De Vivo era opportunamente suggerita in quanto le due famiglie possedevano le più notevoli estensioni terriere; basti considerare che la proprietà del Conte De Fusco, defunto consorte della Contessa Marianna Farnararo, era formata da circa 54 moggi di terra ed alcune case.
(Nicola Avellino – Il Rosario e la Nuova Pompei – n° 4 Gen.-Feb. 1987)
*Una gustosa pagina di storia scritta da un attento e scrupoloso osservatore dell’ottocento in visita a Pompei (Parte Seconda)
Fra le due Stazioni di Scafati e di Pompei (1) il treno si fermò dinanzi ad una graziosa e lillipuziana casetta di legno, un vero chalet, sulla quale era scritto il nome della nuova Stazione: Valle di Pompei (2). A qualche centinaio di metri vidi la Chiesa della Madonna del Rosario, con la sua svelta cupola a mattoni colorati (3), che si eleva maestosamente sopra un fondo verde-scuro ricoperto da una volta di zaffiro.
Alla Stazione mi aspettava un carissimo amico mio, Ludovico Pepe (4) da Ostuni, che dirige e sopraintende ai lavori della Tipografia di Valle di Pompei (5). Questo giovane coltissimo, negli ozii non troppo frequenti della sua professione, si occupa di studi storici ed archeologici, sua vecchia passione, e cerca negli archivi e fruga sotterra i documenti illustrativi di questo paese che va sorgendo presso l’antica città di Pompei, oggi in gran parte dissepolta.
Il Pepe per esempio ha trovato che poco lungi dalla nuova Valle di Pompei esisteva nel medio evo un altro paese dello stesso nome, che fu distrutto nella seconda metà del XVII secolo. Il nuovo è quindi una risurrezione dell’antico paese, e non già della città di Pompei, la quale, sepolta dall’eruzione vesuviana del 79 dell’era volgare, ritornò alla luce soltanto nel secolo scorso, ed oggi resta come uno splendido monumento del tempo romano.
Egli ha raccolto inoltre molti materiali per la Storia dell’antica Valle di Pompei, notata dagli storici per la prima volta al tempo dei Normanni, nel 1087. Poi divenne comune e quindi feudo della famiglia Piccolomini. La sua vera posizione è là dove oggi sorge il R. Polverificio di Scafati, presso il fiume Sarno e ad un chilometro di distanza dalla chiesa del Rosario.
Quando giunsi in Valle il giorno volgeva già al suo termine e una nebbietta diafana ricopriva con un velo trasparente tutta la pianura. In Valle di Pompei ancora non vi sono alberghi: ma ve ne ha parecchi in quei dintorni.
Il mio Mentore mi condusse all’hotel, che resta più vicino al Santuario, e dove il sole non nasce e non tramonta mai, perché è dipinto goffamente in rosso sul muro che guarda la via che mena da Torre Annunziata a Scafati. È denominato Albergo del Sole e pare una rustica villetta, senza le pretensioni di Diomede, e con tutti gli agi di una libera vita patriarcale. Vi è una casetta in fondo ad un viale ornato di fiori, un’altra sulla via, ed una terza – la sala da pranzo – nella quale valenti pittori han riprodotto con molta arte alcune scene di vita pompeiana dipinte sulle pareti di Pompei.
Il padrone dell’Albergo è Monsu Nicola (6), che all’aspetto pare un vecchio pompeiano sbucato dagli scavi della “via della Fortuna”. È un uomo cortese, pieno di buona volontà, che biascica diverse lingue, e di un’amena conversazione: se Monsu Nicola tira il collo ai capponi, è soltanto su questi volatili, che egli esercita la sua crudeltà!
Nella sera volli percorrere la via che mena verso Torre Annunziata: Fiancheggiata di platani e di aceri giganteschi, larghissima, corre sempre in pianura, rasenta Pompei e quindi si unisce con l’altra che viene da Castellammare.
Di là godei lo spettacolo del Vesuvio in eruzione.
Sul cono centrale sembrava accesa come una grande pira rossastra e alla base di esso, nell’Atrio del Cavallo (7), altre cinque fiaccole rosse uscivano dai crateri di lava incandescente.
Di tratto in tratto dal vertice del cratere centrale, veniva su un globo di fuoco che giunto ad una certa altezza scoppiava, come un razzo di fuochi artificiali producendo una cupa detonazione.
Allora mi ricordai dell’ultima ascensione che avevo fatto sul Vesuvio con il P. Denza, con il Sindaco Giusso e con tutti i miei colleghi del Congresso meteorologico di Napoli nel settembre del 1882.
Si era scelta una orribile giornataccia; ma pure l’escursione riuscì divertentissima. Il cono centrale era tutto involto nelle nubi e sporgeva tra queste il suo capo nereggiante. Noi salivamo si a frotte ruzzolando sui lapilli e sulle scorie, accompagnati da una turba di suonatori ambulanti e di poveri che ci aveva aspettati al varco nei tratti più ripidi della salita.
A mezza via ci fermammo per prendere fiato e fare un po’ si siesta. Allora un bello spirito mi obbligò a spifferare un sonetto a rime obbligate, che voglio qui riferire, come ricordo di quella gita, fatta in mezzo a quelle condizioni speciali di atmosfera:
Colore del giorno
Mentre ascendiam sul Cono del Vesuvio
Tra quelle rupi, un dì bollente lava,
Dall’alto ci minaccia Giove Pluvio;
(E qui un bel verso con la rima amava!).
Sembra tornato il giorno del diluvio;
Brontola il monte e dall’immane cava
Di fumo e di vapor lancia un profluvio;
(Qui perdonate un’altra rima: grava).
Incantevole scena! Dorme il mare
Sotto la nebbia; prendon la cuccagna
I congressisti; strimpella un giullare
Sul mandolino; e, color di lavagna,
Sfonda le nubi e maestoso appare
L’eccelso cono un prete in cappamagna!
Il sonetto, detto lì tra i fumi del “lacryma Christi” (8), non dispiacque, sebbene, come tutte le cose estemporanee sentisse non poco di quella ruvidezza che nasce dall’essere costretti a modellare i pensieri per comodo della rima, come un artista che fosse obbligato a disegnare una figura su cinque punti dati a capriccio. Se ne esce un mostro, la colpa non è poi tutta né del poeta né dell’artista.
Note
(1) Esattamente denominata Pompei Scavi. Da alcuni anni la stazione è stata abolita; essa era ubicata di fronte alla Porta Marina Inferiore, abituale ingresso per i visitatori degli Scavi di Pompei.
Da quel punto al Santuario intercorrevano circa due chilometri che bisognava percorrere a piedi e con difficoltà a causa delle condizioni di dissesto del fondo stradale. A Bartolo Longo premeva eliminare tale disagio per i pellegrini devoti che a raccolta chiamava con tanto fervore presso il Tempio della Vergine. A tale scopo inoltrò le pratiche presso la direzione delle Ferrovie dello Stato incontrando mille ostacoli burocratici e tecnici; invocò l’intervento di altissimi personaggi che perorarono la sua causa e finalmente ottenne quanto desiderava. “Il giorno 6 novembre 1886 superò ogni nostra aspettazione. Il primo treno straordinario e speciale diretto da Napoli a Valle di Pompei, che noi ottenemmo a nostre spese e che fu foriero di tanti e tanti treni, che incessantemente vennero poi, vengono e verranno carichi di pellegrini, di devoti e di benefattori, recò a questa nascente cittadina, che appena pochi anni addietro era una landa deserta, tutta una folla di visitatori ansiosi ed entusiasti, fra questi, personaggi ragguardevolissimi” (B.L.).
Bartolo Longo a sue spese provvide a costruire una stazione ferroviaria (“una baracca in legno”) al punto di fermata del treno e tracciò da questa una strada che conduceva direttamente al Santuario. È l’attuale via Sacra. La stazione e la strada, si ricordi, furono costruite entrambe su terreni di proprietà della contessa Marianna De Fusco, consorte di B. Longo.
(2) Il territorio di Valle di Pompei, diviso e smembrato in zone diseguali, da secoli apparteneva ai quattro comuni vicini. Con la costituzione del Comune Autonomo e la ricomposizione del territorio, avvenuta il 29 marzo 1928, assunse l’attuale denominazione di Pompei.
(3) È la vecchia cupola del Tempio, rivestita di mattoni maiolicati policromi. A seguito dei lavori di ampliamento del Santuario, eseguiti dal 1934 al 1939, essa fu demolita e ricostruita più ampia e più alta come attualmente si ammira. Per motivi di armonia architettonica e per uniformità di stile con la restante nuova copertura della costruzione, i mattoni colorati, furono sostituiti con rivestimento di lastre di rame.
(4) Ludovico Pepe. (Ostuni 1853 – Monopoli 1901). Studioso e storico, dedicò la miglior parte della sua solida e valida cultura e della sua intelligente pazienza di ricercatore all’illustratore delle memorie della sua città natale. Si occupò anche di temi di interesse più generale, quale uno studio sulla rivoluzione in terra d’Otranto (1647-1648). Scrisse su Ignazio Ciaia, glorioso martire della rivoluzione napoletana del 1799: trattò con rara competenza argomenti di archeologia pompeiana pubblicati nel periodico Il Rosario e la Nuova Pompei ed in altre riviste. Nel 1887 videro alla luce le sue Memorie storiche dell’antica Valle di Pompei. Unico lavoro di questo genere e su questo argomento, ad esso ancora oggi bisogna fare riferimento come alla fonte esclusiva più autorevole e veritiera. L’argomento non era stato toccato che raramente ed in modo frammentario prima che il Pepe ne facesse oggetto di una ricerca condotta con rigore storico e suffragata da documenti originali.
A tale proposito si consideri che molti dei documenti di epoca angioina consultati e riportati nel suo lavoro andarono distrutti (incendiati dai tedeschi!) e pertanto l’opera del Pepe è ancora più preziosa a chi volesse riprendere o continuare questi studi.
In occasione della ricorrenza dei primi cinquant’anni del Comune di Pompei (1928-1987), divenuto raro ed introvabile il volume della storia del Pepe, ne è stata curata una ristampa fedele all’originale al fine di commemorare la ricorrenza e principalmente per stimolare gli studiosi a continuare le ricerche storiche sulla Valle antichissima. A Ludovico Pepe il Comune di Pompei ha intitolato una strada. Più meritatamente la Biblioteca Comunale porta il suo nome. In occasione dell’inaugurazione di essa, avvenuta nel 1978, fu scoperto nella Fonte Salutare un busto in bronzo dello storico, opera validissima dello scultore pompeiano Domenico Paduano.
(5) La tipografia fu fondata da Bartolo Longo e denominata del Ss. Rosario. Impiantata il giorno 7 luglio 1884, ai primi di settembre venne già alla luce la “Novena in onore di S. Domenico”, il primo lavoro a stampa subito eseguito per importanza e per la mole di lavoro (circa centomila copie), dal fascicolo n° 9 (settembre 1884) il periodico “Il Rosario e la Nuova Pompei. Immensi l’entusiasmo e la gioia del fondatore: “La Celeste Regina del Rosario ha voluto impiantare presso la Sua Chiesa un altro elemento di civiltà per il Suo novello popolo pompeiano ed un novello produttore di industrie di arti, e questo è la Tipografia; … ed ecco come la fede, quando è operosa, diventa l’apportatrice di novella vita e di vero incivilimento per i popoli. Ed ecco come il cattolicesimo non è nemico del progresso, ma ne è la cagione e valido sostegno” (Bartolo Longo).
Nel 1892, fondato l’ospizio educativo per gli orfani della legge, la tipografia assunse l’attuale denominazione di Scuola tipografica Editrice per i figli dei carcerati e fu trasportata dalla prima sede, che era contigua al Santuario, nell’attuale grande edificio in via Sacra.
(6) Derivato dal francese. Generalmente titolo di rispetto e di riguardo che di solito veniva rivolto a persone di rango elevato o a gentiluomini. Nell’Italia Meridionale in passato (attualmente il termine è in disuso), Monsù era il cuoco per antonomasia, il capo.
(7) Grande valle semicircolare interposta tra il cono del Vesuvio ed il Monte Somma in tempi remoti era denominata la valle del Gigante. In seguito prese l’attuale denominazione di Atrio del Cavallo. Vi si lasciavano infatti in sosta i cavalli dei visitatori che si accingevano a scalare il cono del Vesuvio.
(8) Famoso vino prodotto già da tempi antichissimi con uve giunte a perfetto grado di maturazione. L’etnologo Gaetano Amalfi racconta: “Quando Cristo girava per il mondo capitò sul Vesuvio donde gli si fece ammirare Napoli. Allora egli commentò che il golfo era un pezzo di Paradiso abitato da birboni. Così pianse e le sue lacrime cadute al suolo fecero germogliare viti. Dall’uva di quelle viti fu prodotto il vino Lacrima Christi”. (Nicola Avellino)
(Nicola Avellino – Il Rosario e la Nuova Pompei – n° 4 Marzo-Aprile 1987)
*Una gustosa pagina di storia scritta da un attento e scrupoloso osservatore dell’ottocento in visita a Pompei (Parte Terza)
Nel Mattino seguente mi diressi di buon’ora a Valle di Pompei, che resta un 200 metri lontana dall’Albergo del Sole. Quivi giunto visitai la nuova chiesa, l’ospizio annesso e le officine. Vi trovai l’Avv. Signor Bartolo Longo che io già conosceva di nome, e che mi accolse con quei modi squisiti e affettuosi che gli sono propri. Ed egli mi condusse ad ammirare l’opera sua.
Il Longo è il vero fondatore di Valle di Pompei. È nato in questa mia provincia, in Latiano, e non ha raggiunto ancora il mezzo secolo (1); ma è un uomo di una attività prodigiosa e di una tempra di acciaio. Egli ha stampato nel suo cervello il motto del Quetelet, tanto vero in pratica: l’homme qui tends toujours vers le méme but, finit par acquérir une force morale immense (2).
Risultato fecondissimo di questa immensa forza morale, acquistata dal Longo con il suo carattere intraprendente, con il suo tenace buon volere ispirato e avvalorato dal sentimento religioso, sono appunto: la chiesa di Valle di Pompei, dedicata alla Regina delle Vittorie (3), l’asilo d’infanzia, l’ospizio di mendicità, le scuole per i bambini raccolti per le vie e guidati ad essere probi, onesti e laboriosi cittadini nell’età adulta (4).
A conseguire questa che io direi, mi si passi la frase un po’ secentistica, incarnazione delle tre virtù teologali a beneficio delle società, oggi concorrono spontaneamente credenti e miscredenti di ogni parte del mondo, perché la carità è una religione universale e fondamento di quella cristiana; è il mistico anello che lega i popoli di diverse religioni verso un ideale santissimo a cui tutti aspirano e che tendono di conseguire, o su questa terra o nella vita d’oltre tomba.
Per raggiungere questo risultato veramente prodigioso il Longo cominciò dall’istituire presso la chiesa una tipografia e la fornì delle migliori macchine e di bravi operai (5). Da questa officina vien fuori mensilmente un periodico religioso (6); ed in essa si pubblicano edizioni di lusso, splendidissime. Da questa fiaccola del sapere, che centuplica il pensiero dell’uomo, si irradiano in tutte le parti del mondo a centinaia di migliaia di libri di preghiera ed il Rosario e la Nuova Pompei. Le ragazze e le fanciulle pompeiane lavorano qui nella legatoria annessa alla tipografia ed imparano ad essere buone massaie e soprattutto oneste (7).
Lì presso è l’ufficio postale (8) e quello telegrafico (9); il primo dei quali per l’importanza che ha avuto in soli due anni è già divenuto governativo di 2ª classe. Mi assicurano che oggi si fa la spedizione media annua di oltre 20 mila tra lettere, cartoline e pieghi (10); il che vuol dire che il governo incassa circa settemila lire di soli francobolli. E siamo ancora sul nascere di Valle di Pompei!
Di contro a questi due uffici sorge il Santuario ed annesso a questo vi è un grandioso palazzo destinato ad asilo d’infanzia (11) e ad ospizio di beneficenza. Questo fu inaugurato nel Novembre scorso; quando io lo visitai era ancora in costruzione. Si direbbe venuto su d’un tratto, come Minerva dal cervello di Giove. Ed oggi raccoglie più di cento bambini che prima erravano vagabondi, destinati adulti a popolare le prigioni.
D’innanzi a quella colonia d’infelici che mi sfilarono nel corridoio del piano inferiore, io mi sentii allargare il cuore. Si creda o non si creda, d’innanzi a quello spettacolo ci si sente migliori e degni della nostra differenza specifica nella serie zoologica! È questa una religione operosa, la quale non si mantiene nella sola sfera delle relazioni tra il sensibile e il soprasensibile, tra la creatura e il suo Fattore, ma diviene madre amorosa che alimenta i suoi figli e ne guida i passi vacillanti. Quando parla poi la carità, la fede regna sovrana nel cuore dell’uomo; il negarlo è un voler illudere se medesimi!
Note
(1) Bartolo Longo nacque il giorno 11 febbraio 1841 a Latiano, in provincia di Lecce (oggi provincia Di Brindisi) da Bartolomeo e da Antonia Luparelli. Morì a Pompei il 5 ottobre 1926. È stato beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 26 ottobre 1980. Le sue spoglie sono esposte alla venerazione dei fedeli nella Cripta del Santuario. Al fine di appagare un ardente desiderio del Beato, la teca di cristallo che racchiude il simulacro è stata sistemata sotto il Trono della Vergine.
(2) L’uomo che tende costantemente allo stesso bersaglio, finisce per acquisire una forza morale immensa.
(3) Esattamente il Tempio è dedicato alla Vergine del SS. Rosario: “Virgini SS. Rosarii Dicatum” si legge, scritto a grandi lettere di bronzo, sulla facciata del Santuario. Regina delle Vittorie invece, è un appellativo caro a Bartolo Longo, uno dei tanti con cui sovente il Beato invocava la Vergine.
(4) ”Se vogliamo salvare la società, cominciamo per tempo ad educare cristianamente la generazione che sale: I fanciulli. Nessuno si creda esentato da quest’opera di rinnovamento morale della società per mezzo dell’istruzione religiosa e della pratica dei sacramenti”. In tali termini si era espresso Leone XIII; nell’insegnamento del Papa, Bartolo Longo trova la conferma di quanto già da tempo aveva intuito, più di tutto, lo stimolo ed il fervore ad iniziare in Pompei un’opera educativa ad affiancare a quella religiosa. Nel 1881 il primo passo. A fianco del Santuario ancora in costruzione, Bartolo Longo fece costruire “quattro mura rustiche”, un modesto locale nel quale cominciò ad accogliere la domenica pomeriggio una ventina di fanciulli figli di contadini della Valle, ai quali impartiva i primi rudimenti del Catechismo. L’anno seguente, 1882, con il 1° gennaio l’inaugurazione dell’opera Catechistica Pompeiana. L’istruzione è riordinata su altre basi: vengono formati due circoli separati per i fanciulli e le fanciulle, si aggiungono anche gli adulti ai quali Bartolo Longo aveva anche assicurato che a chiunque fosse venuto la sera a trovarlo avrebbe fatto insegnare il leggere e lo scrivere. Mirabile lo sviluppo della scuola: dopo il primo anno era frequentata da un centinaio di fanciulle ed altrettanti fanciulli, una quarantina di uomini, una ventina di donne.
(5) ”Oltre della scuola serotine in Valle di Pompei, a cui accorrono fanciulli e giovanetti per apprendere i primi rudimenti delle lettere e della morale, abbiamo a nostre spese iniziato una scuola particolare per tutti quei fanciulli che già lavorano nel nostro opifizio, al fine di farli diventare un giorno artisti perfetti ed istruiti, vuoi tipografi, vuoi legatori, vuoi macchinisti. E per incoraggiarli a studiare e coltivare lo studio della lingua italiana, tanto per capire quel che stampano, li provvediamo a nostre spese di libri, di carta, di penne e di ogni altro occorrente, facendoli ammaestrare da un idoneo maestro patentato” (B.L.).
(6) Si riferisce al Periodico “Il Rosario e la Nuova Pompei” che vide la luce con il primo, il 7 marzo 1884 stampato però a Napoli dalla Tipografia di A. e S. Festa. “Se Dio vorrà, nella nostra casa apriremo una sala di lavoro per i fanciulli pompeiani e cominceremo con l’impiantarvi una tipografia la quale avrà nome dal Rosario” (B.L.). La Tipografia in breve volgere di tempo fu impiantata; nell’agosto 1884 e già pronto per la stampa il primo lavoro: la Novena ad onore di S. Domenico. Il numero nove del periodico, settembre 1884, è impresso in Valle di Pompei dalla tipografia del SS. Rosario.
(7) “Ed una sala di lavoro di già è aperta per le fanciulle che imparano a piegare, cucire e legare il giornale ed I libri che vengono qui stampati. Confessiamo l’immensa soddisfazione nel vedere queste fanciulle ripulite ed educate, attendere con gran diligenza al lavoro; apprendono l’arte e di già ogni settimana cominciano a portare alle loro famiglie il lucro delle loro incipienti fatiche” (B.L.).
(8) L’Ufficio Postale fu istituito nel maggio del 1884 come Collettoria di Valle di Pompei. Con il 1° dicembre 1885 fu già elevato ad Ufficio Postale di II Classe.
(9) Il giorno 16 del corrente luglio (1886) dovrà essere qui a Valle definitivamente impiantato il nostro ufficio telegrafico. Stampa, Telegrafo e Vapore sono le tre cose di cui non sa far a meno la civiltà moderna, e queste tre cose abbiamo già ora a Valle di Pompei. La nostra tipografia è già ormai contata tra le migliori; in qualsivoglia giorno dell’anno il treno tra andata e ritorno, ferma due volte a Valle di Pompei; e il filo telegrafico ci porterà sulle ali del vento dai nostri associati i comandi a noi e le suppliche a Maria.
(10) Per farsi un’idea di quale rilevanza fosse l’incremento annuo del movimento postale e la mole di materiale spedito, basti osservare che nell’anno 1894 Bartolo Longo inviò in tutto il mondo, dall’ufficio postale di Valle di Pompei, 801225 copie del periodico, 60.018 lettere, 25.889 pacchi e plichi, 1.253 telegrammi. Per il tutto spese lire 29.832 ed 87 centesimi.
(11) La prima opera di beneficenza in Pompeo: gli asili di infanzia: “A questo scopo pensammo di compiere ogni atto di fede nostra con un’opera di carità: aprire cioè un asilo che raccogliesse le miserie, ma le miserie innocenti, che sarebbero la rovina loro e di tanti se lasciate nella ignoranza e nella brutalità. È questo il palpito più sentito del nostro cuore” (B.L.). I rudimenti di quest’opera risalgono già al 1884, in occasione della festa del Rosario ed in quello stesso giorno Bartolo Longo cominciò ad accogliere nei locali contigui al tempio i bambini e le bambine figli degli operai che, impegnati nella costruzione della Chiesa, erano costretti a lasciare i loro bambini abbandonati a se stessi per tutto il giorno. Dopo appena un anno sono già circa sessanta i bambini accolti nell’asilo; B. Longo, pienamente soddisfatto per quel successo, provvide alla costruzione accanto al Santuario di due corridoi con vaste sale “aerate ed acconce” ed il sei novembre del 1886 con solenne cerimonia aprì ufficialmente l’Asilo Infantile distinto in due sezioni per bambine e bambini. Nel breve discorso inaugurale il Beato, con meritato orgoglio, tenne a precisare: “quattro anni addietro, il vostro piede, o signori, avrebbe calpestato qui rape e lupini… Quasi tutti questi bambini erano scalzi, a molti i cenci cadevano di dosso, li abbiamo vestiti e calzati. Vengono qui come piccoli selvaggi e il primo progresso che essi fanno nella via dell’incivilimento è il nettarsi il viso e spogliarsi degli insetti che facevano di quei corpicini aspro governo” (B. Longo).
(Nicola Avellino – Il Rosario e la Nuova Pompei – n° 3 Maggio-Giugno 1987)
*Una gustosa pagina di storia scritta da un attento e scrupoloso osservatore dell’ottocento in visita a Pompei (Parte Quarta)
Dall’ospizio passai al Santuario che fu la meta della mia escursione. Come in Pompei i tempi pagani, così qui la chiesa dedicata alla Vergine non è soltanto la casa di preghiera, ma un santuario dell’arte (1), ed aggiungerei anzi un monumento sincrono dell’arte napoletana.
Quando io la visitai nel settembre scorso era tutt’ora in costruzione. L’intempiatura generale era terminata, come pure le decorazioni dell’absida, della Cupola e della nave trasversale. L’architettura è del chiarissimo Prof. Antonio Cav. Cua (2) ed è opera magnifica. È una chiesa a croce latina, ricca di doratura e di freschi e forse fin troppo ricca (3). Ma prima di giudicarla bisogna metterla in relazione con i luoghi in mezzo ai quali sorge, luoghi pieni di tinte gaie, calde, pittoresche. Bisogna guardarla sotto il cielo di Napoli, in mezzo a quella popolazione ricca di fantasia e semi-orientale. Allora quello sfarzo che colpisce l’occhio intona con il resto del paesaggio ed armonizza con questo.
Sotto la volta dell’absida il Cav. Vincenzo Paliotti (4) ha dipinto un gruppo di angeli bellissimi che via via, sollevandosi verso il cielo e intrecciandosi con quelli dei piani sovrapposti, fa corona all’Altissimo che è in atto di benedire.
Il sommo pittore di tanti velarii e siparii di teatro ha voluto mostrare che il suo pennello risponde egregiamente anche alle sublimi ispirazioni dell’arte religiosa. E questo ci fa dimenticare l’effetto un po’ teatrale di alcune scene, di alcune figure.
Si costruiva in quel tempo il tabernacolo dell’altere maggiore con marmi dei Pirenei e di Carrara (5). I cinque angioli di bronzo, che dovevano essere collocati ai piedi del trono della vergine, erano allora fuor di posto; e così potei ammirare da vicino quell’opera che fa molto onore al Cav. Salvatore Cepparulo (6), napoletano, il quale ispirandosi nelle opere stupende di Donatello e di Mino da Fiesole ha saputo soffiare l’alito della vita nella informe materia.
Mi mostrarono pure due statue scolpite in marmo bianco dal Commendatore Federigo Maldarelli (7) di Napoli e rappresentanti una “l’orazione mentale del Rosario, l’altra “L’orazione vocale (8). È questa la prima volta che il valente artista ha sostituito lo scalpello al pennello. Però, tutti gli intelligenti di arte preferiranno di ammirare il Maldarelli pittore nello stupendo lavoro dell’estasi di Santa Caterina da Siena (9) che decora uno degli altari di questo tempio e che attrae a sé tutti gli occhi dei visitatori. Questa sola tela basterebbe a richiamare in questo Santuario tutti gli amatori dell’arte ed a mostrare che anche oggi da poche menti elette, e sarei per dire privilegiate, si sente la vera arte religiosa scevra dalle fisime del verismo.
Accanto alla chiesa oggi vi è l’Oratorio dove accorrono i credenti in numero grandissimo, siccome potei notare io stesso nei due giorni che mi trattenni in Valle di Pompei.
Ed ora basta. Ho voluto segnare degli appunti, non descrivere il Santuario della nuova Pompei. L’opera non è ancora compiuta e vi si lavora alacremente per condurla a termine. Mi dissero che vi è una colonia di 250 tra artisti ed operai, occupata a quest’opera meravigliosa, nata dalla fede, alimentata dalla carità e rafforzata dalla speranza di un avvenire migliore.
Il tempio di Valle di Pompei diverrà fra qualche anno il nucleo di un paese; ma già fin d’ora è il più cospicuo centro di attività religiosa artistica e intellettuale di tutta la zona che circonda il monte, “sterminator Vesevo”. Ed io, stringendo la mano all’Avv. Longo, gli dirò nell’orecchio due sole parole: Avanti, Excelsior!
Lecce nel Natale del 1886
Cosimo De Giorgi
Note
(1) “E demmo ordine al nostro architetto Giovanni Rispoli che non guardasse a spese, ma si studiasse di rendere la Chiesa del Rosario di Pompei un monumento di arte religiosa moderna da contrapporre ai monumenti dell’arte pagana antica”. (B.L.).
(2) Bartolo Longo ci narra nella sua Storia del Santuario come il professore dell’Università di Napoli Ing. Antonio Cua (1818-1889) si offrì a dirigere gratuitamente i lavori del Tempio. Riportiamo il racconto operando qualche taglio (doloroso) impostoci dalla tirannia dello spazio. Siamo nell’anno 1886. “Mi recai a casa di un intimo e cordiale mio amico, il Cav. Tarquinio Fuortes (1848-1927), professore di matematica. Quel mattino lo trovai circondato dai suoi di famiglia che facevano accoglienze ad alcune signore ed a un signore grave di aspetto e di età. Senza preamboli entrai a discorrere dei fatti occorsi a Pompei. Quello sconosciuto, poi che mi ebbe udito alquanto, interruppe: “Chi è l’architetto che dirige i vostri lavori? – Non abbiamo architetti – risposi -. – Avete almeno un disegno? Ed io pronto, misi la mano in seno e ne trassi quel foglio istoriato che i lettori sanno. Quel signore non seppe ritenere un sorriso di compassione e soggiunse: - Ma perché in un’opera d’arte non valersi dell’uomo dell’arte? – Il compenso di un architetto assorbirebbe metà della somma che raccogliamo con stenti e disagi. – Vi potrebbero essere anche degli architetti che si offrissero gratuitamente. Date a me quel disegno ed io ve lo farò secondo l’arte.
Mi volesse costui fare un tiro, pensai malignamente fra me medesimo, dicendo offrirsi gratuito e poi richiedermi la ricompensa? E guardai negli occhi il mio amico Tarquinio. Costui mi lesse nell’animo ed esclamò: - Bartolo, questo signore è il cavalier Antonio Cua, illustre professore della Regia Università di Napoli, ed è uno degli uomini più buoni di questo mondo. Egli si offre gratuitamente. Balbettai alcune parole di ringraziamento; quindi, quel nobile cuore concluse: - Poiché fate una chiesa a poveri contadini ed a furia di soldi elemosinati, io non solo vi darò il disegno gratis ma ancora verrò ad assistere senza ricompense di sorta alla costruzione e ci rimetterò le spese dei viaggi ogni volta che occorrerà recarmi a Pompei”.
Il professore Cua tenne fede alle promesse, donò il disegno e, per sette anni, dal 1876, diresse di persona e gratuitamente i lavori per la costruzione del Tempio.
(3) “La decorazione: il concetto informatore è di attuare il massimo decoro per la per la casa della Nostra Signora; tutto deve ispirare devozione; ed ogni parte collegata al tutto deve formare la magnificenza del Tempio Cristiano dedicato alla regina dei Cieli.
Il compito è arduo… nulla sarà risparmiato a che la Chiesa raggiunga il suo perfetto e completo risultato. Animati da santo entusiasmo sapremo cavar profitto da ogni cosa…” (arch. G. Rispoli). “… ora una lode a chi aspetta. L’architetto Giovanni Rispoli di Napoli, autore della decorazione e direttore dei lavori, ha speso ogni cura e quanto era in poter suo affinché l’opera riuscisse” (B.L.). All’architetto Rispoli infatti Bartolo Longo aveva affidato la direzione di tutti i lavori che si eseguirono nel Tempio e gli aveva richiesto anche consigli e disegni per la costruzione e l’allestimento di tutta la parte monumentale. Sono suoi infatti la decorazione interna del Santuario, il disegno e l’esecuzione della facciata, il ciborio, l’altare maggiore, la cantoria, il disegno dello stupendo cancello che chiude la balaustra.
(4) Vincenzo Paliotti, romano di nascita, in giovane età si trasferì in Campania dove svolse in prevalenza la sua attività artistica. Si ammirano i suoi affreschi nella Cattedrale di Castellammare di Stabia ed anche in quella di Benevento, nella Chiesa del Gesù Vecchio di Napoli e nella Cattedrale di Capua; il secondo sipario del Teatro San Carlo di Napoli è opera sua; suoi infine alcuni dipinti al palazzo Farnese in Roma. “Vincenzo Paliotti è stato uno di quegli artisti che sin dal principio mi è stato costante compagno nei lavori di questo Santuario ed acuto interprete e fedele esecutore dei miei concetti artistici e dei temi più facili che io soglio porgere ai miei compagni di arte per la più nobile manifestazione delle bellezze cristiane e delle idee puramente ascetiche” (B.L.).
Di tutti i dipinti del Paliotti nel Santuario resta solo una parte; purtroppo durante i lavori di ampliamento del Tempio (1934-1939), alcuni affreschi ed i dipinti della Cupola dovettero essere sacrificati.
La Cupola infatti fu interamente ricostruita più ampia e più alta; l’abside fu arretrata, furono aggiunte le due navate laterali al fine di ricavare maggiore spazio per accogliere i numerosi fedeli.
Attualmente della vasta opera del Paliotti restano: - i quindici medaglioni dipinti su rame che coronano il quadro della Madonna. Rappresentano i quindici misteri del Rosario; - Il soffitto della navata centrale, vasto affresco firmato e datato 1888, vi è rappresentato l’ultimo mistero glorioso con al sommo la trinità che incorona la vergine, il tutto circondato da angeli in atto di omaggio. Nelle ogive sono affrescati San Domenico, San Benedetto, San Francesco d’Assisi e Sant’Agostino. Negli interspazi infine, tra i finestroni, San Pio V e San Paolino; - L’affresco del succielo della cantoria, con Santa Cecilia protettrice della musica e gruppi di angeli assorti nel canto.
(5) Bartolo Longo, fiducioso sempre negli aiuti della Provvidenza, non badava a spese. Il Trono della Vergine e l’Altare Maggiore dovevano essere un autentico gioiello, prezioso e degno, una opera finissima d’arte. Ordinò infatti i marmi più fini e più belli a Carrara ed alla grande Marmerie di Bagneres de Bigorre, negli Alti Pirenei.
“Quel luogo (Lourdes) in cui ventisei anni or sono appariva la regina del Cielo con il Rosario in mano, oggi doveva somministrare i marmi più splendidi per erigere un Trono alla Vergine del Rosario nella Valle di Pompei” (B.L.)
(6) Il de Giorgi si riferisce ai cinque angeli pronto per essere collocati sul piano del Trono. Le sculture sono alte poco più di due metri, modellate dall’artista napoletano Salvatore Cepparulo e fuse dalla ditta Alfano; costarono lire settemilacinquecento. “Il bravo professore S. Cepparulo autore delle cinque monumentali figure, in quello slancio di vena artistica, che forma l’originalità e la nota nuova delle sue stupende produzioni d’arte, in un momento di assai felice vena, si era ispirato ad un ideale ascetico che completamente l’aveva signoreggiato e trascinato a delle figure di uno slancio tale da far restare compresi di ammirazione quanti le hanno vedute” (B.L.).
I cinque angeli furono sistemati sul piano del Trono secondo il progetto del bravo Rispoli. A seguito dei lavori di arretramento dell’Altare si diede nuova e più snella sistemazione a tutto il complesso monumentale. Dei cinque angeli infatti, solo due furono lasciati al loro primitivo posto (come oggi si vedono); altri due sono stati collocati nel parco del Piazzale Giovanni XXIII, il quinto, infine, nei giardini, a destra di chi guarda la facciata del Santuario. Dello stesso artista, si ammirano: sul dorsale dell’Altare Maggiore, sei testine di Cherubini di bronzo a tutto tondo incastonati in altrettanti dadi di marmo nero; il cancello della balaustra, finissimo lavoro di bronzo e d’argento; le statuine dei Padri della chiesa e dei Santi, tra cui S. Pietro e S. Paolo, che circondano il ciborio dell’Altare Maggiore.
(7) Federico Maldarelli (Napoli 1826 – ivi 1893). “Insigne pittore napoletano, nel maggio 1879, per sua specchiata pietà, vedendo cresciuta ogni giorno la devozione di tanti signori napoletani e forestieri verso la Vergine del Rosario di Pompei, la cui immagine per la umidità della Parrocchia era quasi nel totale suo deterioramento, si offerse gratuitamente a fare una più perfetta e completa riparazione” (B. L.). È il secondo restauro del quadro della Madonna; il primo era stato rozzamente eseguito nel 1876 da Guglielmo Galella, “pittore artigiano”. Nel 1965 il quadro fu nuovamente restaurato, finalmente seguendo i moderni canoni dell’arte, presso l’Istituto del Restauro dei Monaci Benedettini Olivetani in Roma.
(8) Le due statue sormontavano i portali di marmo che si aprivano ai due lati del Trono. A seguito dell’ampliamento del santuario, i due portali furono aboliti e le due statue ebbero diverse collocazioni. Attualmente esse si possono ammirare nella Cripta del Santuario, ai lati dell’altare.
(9) Pregevole lavoro del Maldarelli, firmato e datato 1883. Raffigura Santa Caterina che riceve le Sacre Stimmate dal Crocifisso apparsole in estasi. Attualmente il quadro è collocato nel penultimo altare alla destra per chi entra nel Santuario.
Da notare, sotto la mensa dello stesso altare, una copia in marmo della Santa Cecilia del Maderno.
(Nicola Avellino – Il Rosario e la Nuova Pompei – n° 5 Settembre-Ottobre 1987)
Un altro lavoro, anche di gran lena, ci sta dinanzi, e ora solo in parte compiuto, vogliamo dire la Sagrestia, degna del Santuario e consona alla rimanente ricchezza d’arte.
Il nostro tempio è già fornito di spaziose sale destinate a quest’uso: Vi è un ampio salone, che viene sfarzosamente decorato in guisa, da un cedere al paragone delle più lodate Sagrestie delle grandi città, massime di quelle di Firenze.
Nelle altre parti le dorature sono terminate, e vi si lavora in pittura. Le volte soni già compiute.
Possiamo fin da ora accennare all’esito felice di tre fra i principali dipinti: essi sono la Cena, l’Assunzione di Maria e la Nascita di Gesù Bambino, Di pari pregio, sebbene di importanza minore per il posto assegnato loro fra gli spazi delle decorazioni, sono le pitture che rappresentano Gesù che calma la tempesta, la Samaritana al pozzo, Gesù fra i dottori, il Calvario: ed, in altre parti, i fatti della Storia di Giuseppe, ove è fedelmente riprodotta la scena orientale.
Da questo breve cenno i nostri lettori vedono sommariamente quel che si è eseguito nel Santuario di Pompei nello scorso anno 1886, e quel che ci proponiamo di menare a termine prossimamente. Piaccia alla Vergine del SS. Rosario, che coronò, sempre pietosa, i nostri sforzi, di benedirci anche per l’avvenire, e far paghi i voti di quanti zelano per la sua Casa e per la sua gloria.
(Autore: Bartolo Longo)
Ě costruita a doppio ordine, con portico a tre arcate, sul modello delle basiliche romane, tutta in travertino del monte Tifana, in S. Angelo in Formis (Caserta): la stessa pietra servì a Masuccio Secondo per la torre di S. Chiara in Napoli (1328) ed a Luigi Vanvitelli per il palazzo reale di Caserta (1752). Su progetto del prof. Arch. Giovanni Rispoli, di Napoli, la costruzione fu iniziata il 15 maggio 1893, ed inaugurata il 5 maggio 1901.
Il costo di £. 1.700.000 fu coperto da raccolte, anche minime, tra 4.000.000 persone che da ogni paese risposero all’iniziativa di Bartolo Longo. Nelle intenzioni del Beato doveva essere, e realmente fu, il plebiscito del mondo per la pace universale.
Essa fu cominciata prima che lo Czar di Russia convocasse le potenze al Congresso dell’Aia. Bartolo Longo fu anche invitato a partecipare al Congresso Internazionale di Glasgow ed i promotori di esso ne proposero la candidatura al premio Nobel per la Pace.
La proposta fu accantonata perché avversata da alcuni di ispirazione laicista, ma il Longo fu eletto membro della celebre Howard Association di Londra e socio onorario di molte società filantropiche in Europa ed in America. L’ordine inferiore del monumento è di stile ionico, decorato da quattro colonne binate di granito rosa, lucidate a specchio nel corpo centrale, e di capitelli marmorei sui pilastri delle arcate. Tra i due ordini corre un fregio di granito con la scritta in lettere cubitali di bronzo:
VIRGINI – SS. ROSARII – DICATUM
L’ordine superiore è di ricco stile corinzio con colonne binate di granito grigio, cornicione e timpano di mensole scolpite.
Al centro si apre la Loggia Papale
Bartolo Longo non si perse in commenti, non recriminò, ma non rinunziò alle colonnine, ormai della Madonna. E pagò quanto e come venne richiesto, annotando: pagammo con l’oro della Madonna.
Il 21 ottobre 1979, il Papa Giovanni Paolo II, in visita a Pompei, si affacciò dalla Loggia per la recita dell’Angelus e per impartire la benedizione alla folla presente ed al mondo intero.
Si avverava una profezia del Beato: ”un giorno, da questa loggia vedremo la bianca figura del rappresentante di Cristo benedire le genti accolte in questa piazza, acclamanti la Pace Universale
A coronamento del finestrone della loggia, un angelo di bronzo, e più in alto lo stemma marmoreo di Leone XIII. La facciata culmina con la colossale statua della Vergine del Rosario, opera dello scultore Gaetano Chiaramente, ricavata da un solo blocco di marmo di Carrara, del peso di 180 quintali.
In corrispondenza dei due finestroni laterali, in due tondi, sono posti un orologio elettrico a sinistra ed una meridiana sulla destra.
Alle spalle della “Loggia Papale”, in un vastissimo salone, è sistemato l’Archivio Storico Bartolo Longo dove sono custoditi innumerevoli documenti storici. Nel pronao della Basilica si aprono quattro nicchie con le statue del beato Luigi Guanella, (Arnaldo Gelli – 1970) del beato P. Ludovico da Caloria (Arnaldo Gelli – 1970) di Santa Francesca Saverio Cabrini (Domenico Ponzi – 1970) e S. Leonardo Murialdo, fondatore dei Giuseppini (Domenico Ponzi – 1970).
Proseguendo sul lato destro si può ammirare l’imponente mole dell’edificio.
L’esterno, tutto in travertino di Tivoli lavorato a massi, poggia sopra una fascia di granito che corre tutt’intorno alla Basilica.
Sono di granito rosa le colonne a sostegno del cornicione e quelle binate della cupola (del peso di 85 quintali ciascuna) e dei cupolini.
La cubatura totale è di 40.000 metri ,
La copertura metallica della grande cupola, dei cupolini, dei tetti e delle semicalotte sulle cappelle, richiese kg. 55.000 di rame fornito e messo in opera dalla ditta di Saverio Ascolese della vicina città di Sarno. La fornitura dei marmi e la loro lavorazione furono affidate alla ditta Paolo Medici e figlio di Roma.
Intorno, a destra, un ampio giardino di circa 1.500 mq. Che crea un comodo accesso alla Basilica ed alla Cripta.
In questo giardino, trovasi il monumento a San Massimiliano Maria Kolbe, opera di Tarcisio Musto, frate minore conventuale, inaugurato il 16 ottobre 1976, ed uno dei cinque angeli (opera del Cepparulo) che erano sul trono originario della Madonna nel 1887.
*Inaugurazione della facciata del Santuario di Pompei
Quel 5 Maggio del 1901
“La Sposa dalla faccia bella”
Con queste parole Bartolo Longo indica l’inaugurazione della facciata della Chiesa di Pompei. Il monumento fu costruito con offerte raccolte in tutto il mondo mediante moduli di sottoscrizione ricoperti da oltre 4 milioni di firme.
"Fratelli e sorelle sparse per l’orbe, il Monumento promesso è già innalzato: io vi aspetto il 5 Maggio, prima domenica del mese sacro alla regina del Rosario di Pompei di questo anno giubilare del Santuario pompeiano (1876-1901).
L’invito, o fratelli, è per voi. Il voto, per me. L’augurio per tutti. Vorrei che la mia lingua sapesse tradurvi tutta la foga dei sentimenti, di speranza, di conforto, di giubilo, di vittorie, che si avvicendano nella mia mente e nel mio cuore ogni volta che mi pongo a pensare quel giorno solenne e memorabile, quando si mostrerà la “bella faccia” di questa novella sposa di Cristo. Io amo la Chiesa di Pompei come sposa dell’animo mio a cui ho consacrato tutti gli aneliti e gli affetti più vivi del mio cuore. Essa è l’oggetto dei desideri per tanti anni nutriti, tra le ansie e le trepidazioni di un cammino arduo e difficile; ed essa sarà la corona della mia vita” (B.L.).
Abbiamo raccolto qua e là degli scritti di Bartolo Longo, pubblicati al cadere del secolo scorso e, di proposito ci asteniamo ad ogni commento per evitare di materializzare espressioni così preziose di intensa spiritualità: l’incanto mistico di un cuore così ardente di fede. Autore del progetto della facciata, fu il Cav. Giovanni Rispoli, napoletano, “ormai per Lui il Tempio di Pompei è la cosa più cara che abbia al mondo. Che i risultati ottenuti gli siano di sprone a raggiungere quella meta che tanto agogna, e che formar dovrà la pagina più preziosa della sua vita artistica” (B.L.). Il Rispoli, professore onorario del Regio Istituto delle Belle Arti di Napoli, architetto di valore, artista geniale, concepì la grande facciata del Santuario Pontificio Pompeiano con amore infinito; sorretto da fede profonda ne diresse magistralmente i lavori alla guida di uomini di fatica, di operai, di artisti.
“Con sentimenti di ammirazione e di gratitudine segnaliamo i nomi della gloriosa falange di artisti, impresari, capi d’arte e fornitori della Facciata Monumentale del Santuario di Pompei.
Uomini valorosi, cui tributiamo il nostro reverente saluto e quello degli innumerevoli devoti di questo Santuario” (B.L.).
Il materiale per la costruzione, era tutto di origine italiana. Bartolo Longo, con orgoglio quasi campanilistico, in un appunto aveva scritto: “Tutto materiale italiano e lavorato da operai italiani in maggior parte della provincia di Napoli e Salerno”. Per la facciata in prevalenza fu impegnato il travertino. Il calcare fu estratto dai fianchi del Monte Tifata, della catena degli Appennini, presso Capua. È uno dei migliori travertini: basti pensare che di esso si servirono Masuccio II, nel 1328, per la costruzione della famosa torre campanaria di S. Chiara in Napoli e, nel 1752, il Vanvitelli per la famosissima Reggia di Caserta. Le cave però erano state abbandonate; B. Longo, con enorme dispendio, le rinnovò affinché la facciata del Santuario di Pompei fosse costruita con gli stessi materiali già adoperati per il Campanile così famoso e per una Reggia così splendida. Al travertino si aggiunse il granito di Gravellona-Toce, ed il bianchissimo marmo di Carrara. Solo per le due piccole colonne che decorano la loggia papale, fu impiegato, per la prima volta in Italia, il granito rosso di Finlandia. Gli unici due pezzi stranieri sulla facciata del Tempio. A tale proposito B. Longo scrisse: “Anche la Russia ha avuto il suo contingente di benefici: pochi benefici spirituali invero, poiché il suo governo non permette la diffusione di stampe cattoliche, ma la Russia ha mandato le colonne preziosissime di granito rosso della Finlandia che adornano la loggia papale della facciata ed ha ricevuto in cambio l’oro di questo Santuario”. “L’opera pompeiana è l’opera della pace universale, 1900).
La spesa complessiva sostenuta per la costruzione dell’intero Monumento ammontò ad un milione e settecentomila lire; era costruita dalle generose offerte raccolte in tutte le parti del mondo mediante moduli di sottoscrizione ricoperti da oltre quattro milioni di firme. I moduli, rilegati, formano una serie di otto grossi volumi e rappresentano il plebiscito dei popoli per la pace universale, secondo il concetto espresso dal promotore del plebiscito stesso: l’Avvocato Bartolo Longo.
La cerimonia dello scoprimento della facciata era stata fissata per il 5 Maggio del 1901 alle ore 12. Il programma della solenne inaugurazione del Monumento, pubblicato in marzo dello stesso anno, prevedeva, tra l’altro, a grandi linee: L’esecuzione dell’inno della pace universale ed il discorso di Bartolo Longo incentrato sul ringraziamento solenne delle persone che con la fiducia in Lui, con l’offerta e la fede, avevano consentita la realizzazione di un’opera oltremodo ardimentosa. Alle ultime parole dovevano cadere gli ampi velari che coprivano la novella facciata mentre echeggiavano le note della marcia trionfale eseguita dalle bende musicali riunite; in concomitanza, le campane del Santuario, suonando a distesa, avrebbero annunziato a tutta la Valle del Sarno l’inaugurazione del Monumento alla Pace. Non sarebbero mancati i rituali spari di mortaretti e l’accensione di una miriade di bengali. A chiusura, nutriti stormi di colombi viaggiatori, sprigionati dalle arcate della loggia, avrebbero raggiunto, forieri della lieta novella, le città lontane.
Il programma fu rispettato con meticolosa puntualità. Il 5 Maggio alle ore 12 precise, gli ampi velari che coprivano la facciata caddero; immenso fu lo stupore della folla che si accalcava sulla piazzetta antistante, sui balconi, sui terrazzi dei caseggiati; quelli più lontani si erano persino muniti di binocolo. Il discorso di Bartolo Longo commosse tutti; a noi piace riportare testualmente un passo, forse il più accorato. L’oratore si rivolge agli operai. “Operai, fratelli miei che per venticinque anni siete stati a me vicini ed insieme abbiamo lavorato, voi con le braccia ed io con la mente, tutti con amore. Fratelli operai, oggi il nostro lavoro è compiuto. Noi ci dovremmo separare, ma i nostri cuori non saranno giammai separati, tra noi ci sarà un perpetuo legame: Gesù Cristo, il primo operaio che è pure la nostra comune aspettazione. E quando io scenderò da questo luogo e mi avvicinerò a quel Monumento, che voi con tanto amore avete lavorato, io bacerò il piedistallo della prima colonna, e baciandolo intendo baciare ed abbracciare tutti gli operai che hanno messo mano a questo Monumento” (B.L.).
Il Maggio del 1901 compendiava i primi 25 anni di storia dell’opera religiosa e sociale in Valle di Pompei; un’impresa singolare sorta nel mezzogiorno d’Italia tramite l’erezione di un Santuario redimito di prestigiose istituzioni sociali, caritative, educative. Si concludeva il primo grande ciclo dell’avventura pompeiana di Bartolo Longo. Un quarto di secolo storicamente più importante, essenziale, più fruttuoso perché ispirato e guidato dalla Provvidenza. (Autore: Nicola Avellino)
“Nel 1934 ho iniziato a lavorare, quale scalpellino in architettura, nella Basilica di Pompei, fino al 1939. Ho trattato pietre provenienti da tutto il mondo: dal Belgio, dalla Francia, dall’Australia, dal Canada, dalla Russia, da Trani, da Carrara e dal Piemonte con il suo granito cipollino o rosso”.
È la viva testimonianza del sig. Marino Machetti, anni 76, che venne a lavorare per l’ampliamento del Santuario di Pompei, un anno dopo l’inizio dei lavori e che ancora oggi, quando entra in Chiesa, tutte le sere per la Messa prova “una grande emozione nel vedere le colonne” che egli stesso ha contribuito a mettere in opera (30 tonnellate ciascuna), con una fatica certamente improba, se si pensa che i mezzi tecnici non erano quelli attuali. Dinanzi allo straordinario, crescente, - forse anche inatteso nella consistenza – coinvolgimento dei fedeli, dinanzi all’interesse del mondo per Pompei, l’originario disegno del luogo di preghiera formulato da B. Longo si rivelava ormai inadeguato, insufficiente: di qui il dilemma se optare per una nuova Chiesa o ampliare quella già officiante. Non si trattava, infatti, di semplice problema di spazio, ma anche di rispetto verso l’esistente, e cioè verso quella struttura eretta da B. Longo e consacrata nel 1891, che era costata sudore, sacrifici, impegni, entrata a far parte ormai della memoria della marianità del popolo, costituita oggi dalla navata centrale fino alla crociera. Prevalse così la seconda ipotesi: l’architetto archepito fi Mons. Spirito Chiappetta, delegato espressamente dal Vaticano. “Con me, prosegue Marino Machetti, hanno lavorato i geometri Rossi e Bellone, proveniente quest’ultimo da Milano, c’erano Masto Michele (Capo ferraiolo), l’assistente Giardini, che curava la muratura ed Erminio, che curava la carpenteria, c’era Pietro Vitiello che ha fornito puzzolame, breccia, arena e che trasportava tutto il materiale con traini e carrette”.
Dietro tutto questo, il Prelato Mons. Anastasio Rossi, Patriarca con la sua fermezza, la piena consapevolezza di dover dare alla preghiera del Rosario e della Supplica un’atmosfera di più ampio respiro, più preziosa persino nei particolari, generosa nei marmi delle colonne, nelle pitture. “I meravigliosi affreschi dell’abside, della cupola e di quant’altro pertinente la lunghezza della Basilica, furono eseguiti in gran parte dall’emerito pittore prof. Landi. Il rivestimento in rame della cupola centrale e di quelle laterali più piccole, fu eseguito dalla ditta Ascolese da Sarno. Per ampliare fu eliminata la vecchia sacrestia, il corridoio che immetteva nella canonica dei sacerdoti e un ampio giardinetto… anche la scala di accesso per salire in Prelatura fu abbattuta…”.
È il prof. G. Clemente che parla con i suoi ricordi, la voce emozionata dei suoi 78 anni. I tempi di attesa i pompeiani li trascorrevano seguendo le trasformazioni che i lavori creavano nel monumento, mentre raccoglievano e ricevevano i contributi che la Provvidenza non aveva mai lesinato. Dall’inizio dei lavori, il 2 ottobre 1933 ultimo dei 15 sabati in preparazione alla festa del S. Rosario, alla consacrazione del 6 maggio 1939, sarebbero passati quasi 6 anni.
“La nuova Chiesa che viene a coprire una superficie di circa 2.000 metri quadrati è cinque volte più grande della precedente che misurava solo 421 mq. La cupola si spingeva a soli 29 metri di altezza, mentre l’attuale innalza la sua croce a 57 metri dalla piazza”; è quanto si legge in una monografia del 6 maggio 1939, quando il Cardinale Luigi Miglione, segretario di Stato di Pio XI, il Papa dei progetti arditi, compie la consacrazione.
Dalle pagine del periodico, nel numero maggio/giugno 1939, parte la descrizione del grande avvenimento, ripreso, peraltro, dai giornali del tempo, diffuso radiofonicamente. Si trattò di un momento edificante, perché l'ampliamento dell’a Basilica, al di là della sua valenza architettonica e della sua preziosità estetica, costituiva la prova tangibile che il messaggio mariano affacciatosi quasi immediatamente nella realtà locale, per essere ascoltato aveva richiesto una casa più grande, un maggior numero di confessionali, una schiera più fitta di sacerdoti per celebrare, per ascoltare, per diffondere la parola di Dio. Si trattava del miracolo della preghiera, dell’arte, dell’ascolto, della generosità, tutti aspetti che a dieci lustri di distanza si inseriscono in una realtà mariana immutata nello spirito, anche se al passo con i tempi.
(Autore: Luigi Leone)
50° anniversario dell’ampliamento del Santuario
Cinquant’anni fa il Santuario della Vergine del Rosario era cinque volte più piccolo di quello attuale.
Il tempio che lo stesso Fondatore, il Beato Bartolo Longo († 1926), aveva costruito dal 1876, posa della prima pietra, al 1891, si era rivelato insufficiente ad accogliere i devoti che a migliaia affluivano a Pompei. Si rendeva necessaria una soluzione. All’ipotesi di un nuovo Santuario, si preferì, per ragioni affettive, procedere all’ampliamento di quello già esistente. Il progetto dell’architetto, sac. Spirito M. Chiappetta, conciliò le varie esigenze. Occorsero sei anni di duro lavoro (1934-1939), ma i risultati furono estremamente lusinghieri. Il 7 maggio 1939, il nuovo tempio fu consacrato e dedicato da Sua Eminenza il Cardinale Luigi Maglione, Segretario di Stato di Pio XII.
Cinquant’anni, da allora, sono trascorsi e milioni di pellegrini e visitatori hanno con diversità di accenti espresso il loro amore alla vergine ed hanno imparato, guidati da Lei, ad essere “pietre vive” dell’edificio spirituale che è la Chiesa di Cristo. È quanto ha voluto sottolineare il Cardinale Opilio Rossi, Presidente della Commissione cardinalizia per i Santuari di Loreto, Bari e Pompei, intervenuto alla celebrazione dell’anniversario: “Quello dunque che noi ammiriamo qui costruito materialmente deve richiamarci ad una ben più alta realtà, che pulsa all’interno dell’anima nostra; quello che vediamo qui fatto con pietre, deve avvenire, mediante la divina grazia, nei nostri cuori. Dobbiamo essere consapevoli di appartenere all’unica Chiesa di Cristo e di sentire di conseguenza il dovere di essere pietre viventi sviluppando in noi quelle virtù che ci qualificano veri cristiani di fronte al mondo, forti nella fede, consolidati nella speranza, compaginati nella carità. Saremo così pietre inserite nel mirabile edificio di Dio, di cui questa nostra sontuosa basilica è immagine”.
(Autore: Pasquale Mocerino)
Un altro lavoro, anche di gran lena, ci sta dinanzi, e ora solo in parte compiuto, vogliamo dire la Sagrestia, degna del Santuario e consona alla rimanente ricchezza d’arte. Il nostro tempio è già fornito di spaziose sale destinate a quest’uso: Vi è un ampio salone, che viene sfarzosamente decorato in guisa, da un cedere al paragone delle più lodate Sagrestie delle grandi città, massime di quelle di Firenze.
Nelle altre parti le dorature sono terminate, e vi si lavora in pittura. Le volte soni già compiute.
Possiamo fin da ora accennare all’esito felice di tre fra i principali dipinti: essi sono la Cena, l’Assunzione di Maria e la Nascita di Gesù Bambino, Di pari pregio, sebbene di importanza minore per il posto assegnato loro fra gli spazi delle decorazioni, sono le pitture che rappresentano Gesù che calma la tempesta, la Samaritana al pozzo, Gesù fra i dottori, il Calvario: ed, in altre parti, i fatti della Storia di Giuseppe, ove è fedelmente riprodotta la scena orientale.
Da questo breve cenno i nostri lettori vedono sommariamente quel che si è eseguito nel Santuario di Pompei nello scorso anno 1886, e quel che ci proponiamo di menare a termine prossimamente. Piaccia alla Vergine del SS. Rosario, che coronò, sempre pietosa, i nostri sforzi, di benedirci anche per l’avvenire, e far paghi i voti di quanti zelano per la sua Casa e per la sua gloria.
(Autore: Bartolo Longo)
*La nuova Sacrestia
La
nuova Sacrestia, alla quale si accede attraverso un vano nell’abside, è
sistemata dietro il trono della Madonna. Nel breve corridoio di accesso, sulla
sinistra, si trova una pregevole terracotta fiorentina in memoria di Matteo
Della Corte, grande archeologo ed epigrafista originario di Cava de’ Tirreni.
Sulla destra, una lapide ricorda il primo centenario della fondazione
dell’Ordine delle Figlie del Santo Rosario di Pompei. Sulla parete di fronte,
troviamo il monumento di san Pio X, opera di Domenico Ponzi. All’interno della
sacrestia, quattro medaglioni raffigurano i dottori della Chiesa: san Giovanni
Crisostomo, sant’Ambrogio, san Giovanni Damasceno, san Bernardo, tutti opera
del pittore Fermo Taragni da Bergamo (1937-1938).